.
livello elementare
.
ARGOMENTO: STORIA NAVALE
PERIODO: XX SECOLO
AREA: GUERRA DI MINE
parole chiave: mine ormeggiate, mine ad influenza, II guerra mondiale
Le mine navali italiane nella II Guerra mondiale
Anche se lo sviluppo della Guerra di Mine fu maggiormente concentrato nel mondo anglosassone e germanico, ritengo opportuno fare un quadro dell’impiego di tali armi da parte della Regia Marina Italiana. La posizione geografica dell’Italia, posta al centro del Mediterraneo, era favorevole all’impiego di campi minati difensivi per limitare la libertà di intervento delle navi alleate. Pur essendo i fondali circostanti la nostra penisola caratterizzati da aree con gradiente batometrici particolarmente elevato [71], non favorevole all’impiego delle mine, dal 1936 la Regia Marina aveva identificato zone idonee per un minamento difensivo da adottare nel caso di conflitto con l’Inghilterra e la Francia [72]. Nel dicembre del 1936, SUPERMARINA stabilì un ordine di priorità legato alla disponibilità delle torpedini e dei mezzi di posa. In particolare fu data enfasi all’identificazione dell’esatta posizione di posa dei campi, stabilendo punti cospicui a terra per l’effettuazione della navigazione di precisione necessaria per il minamento. Questa particolare attenzione da parte dello Stato Maggiore era mirata non solo ad ottenere una maggiore efficacia operativa ma ad evitare errori futuri nei movimenti della Flotta di altura.

mine navali allineate sui binari a bordo sul RN Duca D’Aosta – Foto USMM
Quando la Germania si rese conto dell’impossibilità di invadere l’Inghilterra, e che la situazione sul fronte del Nord Africa stava capitolando, decise di intervenire con le sue Forze nel Mediterraneo dove la Marina inglese aveva la preponderanza strategica. Nel campo della Guerra di Mine si aprì un dialogo fra l’Italia e la Germania al fine di coordinare le proprie Forze, dedicate a queste armi[73]. L’Italia era in possesso di mine ormeggiate posabili fino alla profondità di 800 metri, decisamente maggiore di quelle tedesche (450 metri), ma che potevano essere facilmente dragabili con i sistemi di dragaggio in possesso delle Forze alleate. Ciò era dovuto al fatto che non erano state dotate di sistemi anti-dragaggio invece ampiamente sviluppati dalla Marina tedesca. Dopo la partenza del primo convoglio dell’Afrika Korps, nel febbraio del 1941, le due Marine si incontrarono a Merano stabilendo una politica comune di impiego di tali armi subacquee. In tale convegno fu stabilito che:
- la Marina italiana avrebbe perseguito lo sviluppo e lo studio dell’impiego di torpedini ormeggiate per gli alti fondali;
- la Marina germanica si sarebbe dedicata allo sviluppo di torpedini da fondo, ed in special modo di quelle lanciabili da velivoli;
- le due Marine avrebbero collaborato per lo sviluppo delle contro misure mine.

regio cacciatorpediniere Pigafetta in missione di posamine nel 1941. Ben visibili sulla destra le mine tipo P 200 allineate sulle ferroguide – Ufficio storico MM.
La situazione numerica delle armi era tutt’altro che consolante: l’Italia era in possesso circa 25000 mine, di cui solo 17000 erano state posate, l’industria nazionale non aveva marciato di pari passo con la necessità di impiego, i campi minati pre-pianificati avevano per lo più caratteristiche difensive ed era necessario sviluppare sbarramenti offensivi per costringere i movimenti della Marina britannica. Inoltre, a causa della diversità dello scenario ambientale mediterraneo diverso da quello del Mare del Nord e del Baltico, esistevano delle forti limitazioni operative [74]. Oltre alle mine già presenti dalla Prima Guerra Mondiale (Elia e Bollo), l’Italia poteva contare sulle P200 (costruite dalla ditta Pignone di Firenze.

28 giugno 1941 L’incrociatore Duca d’Aosta durante l’operazione di posa di mine dello sbarramento S. – Foto USMM
Dal 1941, con l’arrivo delle mine germaniche nel Mediterraneo, si resero disponibili le mine da fondo [75], con sensori magnetici ed acustici, e le anti draganti, cioè boe esplosive posate in prossimità dei campi minati per ridurre l’efficacia delle apparecchiature di dragaggio. Fu deciso congiuntamente che le mine da fondo germaniche dovessero essere posate solo dalle unità tedesche dislocate nel Mediterraneo mentre i posamine italiani si dovessero occupare della posa di mine italiane e tedesche ormeggiate nei campi minati offensivi del Canale di Sicilia, strategicamente limitanti i movimento delle forze inglesi, in particolare, provenienti da Malta. In totale, furono inizialmente posate dalla Marina italiana e tedesca circa 29000 mine [76].
Tra i campi minati italiani che diedero i migliori risultati va menzionato quello di Tripoli, il cosiddetto “sbarramento T”, nel quale un gruppo navale britannico, nel dicembre del 1941, perse un incrociatore e due cacciatorpediniere, ricevendo seri danni ad altri due incrociatori. La forza navale inglese era uscita da Malta alla ricerca di un convoglio ed entrò per errore su un campo minato italiano situato a circa venti miglia ad est di Tripoli. L’Ammiraglio Cunningham, nel suo “Odissea di un marinaio” [77] [78], racconta l’episodio in tutta la sua drammaticità ammettendo che, se il campo minato italiano fosse stato posato qualche mese prima, la squadra inglese non avrebbe mai potuto bombardare Tripoli, unico porto italiano in cui potevano confluire i rifornimenti alle truppe dell’Asse dopo la caduta di Tobruk e Bengasi. Le azioni di minamento offensivo perpetuate dalla Marina inglese, dall’agosto del 1940 al giugno del 1943, furono effettuate tramite bombardieri impiegando solo mine da fondo magnetiche soprattutto su obiettivi dell’Africa settentrionale[79]. Nel campo delle CMM, la Regia Marina era in possesso di 38 vetusti dragamine della classe RD da 200 tonnellate, costruiti tra il 1916 ed il 1926. Nel corso della guerra furono incorporati sei dragamine di costruzione jugoslava e sei vedette VAS per il dragaggio costiero alle quali si affiancarono oltre 900 navi civili di piccolo cabotaggio, per la maggioranza motopescherecci, caratterizzati dalle sigle F (dragaggio foraneo ovvero all’interno delle aree portuali), B (dragaggio costiero), G ed R (dragaggio d’altura) e DM (dragaggio magnetico).
Per quanto riguarda le operazioni di minamento, erano in servizio tredici posamine e alcune navi mercantili trasformate per la posa; in realtà molte operazioni di minamento furono effettuate anche dalle navi da battaglia maggiori [80]. Al termine della guerra il naviglio italiano dedicato alla guerra di mine si era ridotto a qualche dragamine ed alle poche unità maggiori posamine che avevano conservato tale capacità [81].
fine parte VII – continua
Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo
PAGINA PRINCIPALE[70] Solo 3.000 mine furono posate con i mezzi della Marina il resto con velivoli bombardieri (la percentuale delle mine posate tramite i B29 fu del 63% sul totale) – dati US NAVY – Archivi US Post Graduate School Monterey CA.
[71] La profondità è un fattore determinante per la pianificazione di un campo minato; nel caso del Mar Mediterraneo, a parte alcune aree come nel Mar Adriatico centro-settentrionale, allontanandosi dalla costa le profondità aumentano rapidamente e riducono quindi la possibilità di effettuare un minamento esteso come quello fattibile nei Mar del Nord, lungo le coste della Manica e nel Mar Baltico. Le scelte di sviluppo delle mine furono durante le due guerre mondiali fortemente influenzate dalle possibili aree di impiego e questo spiega l’indirizzo industriale italiano del settore che mirò allo studio e realizzazione di mine ormeggiate da posare su alti fondali.
[72] Tali aree comprendevano il Canale di Sicilia, l’Alto Tirreno, il Canale di Otranto e buona parte dell’Adriatico. Lo studio dettagliato delle migliori ubicazioni fu devoluto ai Comandi Dipartimentali ed ai Comandi Superiori di Marina in Libia, in Egeo ed in Africa Orientale. Le finalità dei campi minati, stabilite dalla Regia Marina, erano a scopo difensivo, antisbarco ed antisommergibili.
[73] “La guerra di mine”, Ufficio Storico della Marina, vol. XVIII, ediz. 1988
[74] Le limitazioni ambientali sono un fattore fondamentale per la pianificazione dei campi minati. Nel caso specifico, nei mari del Nord e nel Baltico, i bassi fondali potevano consentire minamenti estensivi al fine di chiudere ermeticamente ampie aree geografiche. Ciò non era ovviamente possibile nel Mediterraneo dove esiste un’alternanza batimetrica caratterizzata da alti fondali drammaticamente intercalati da profonde fenditure (canyon) che impedivano l’impiego delle mine se non relativamente sotto costa.
[75] La mina da fondo è un’arma subacquea studiata per essere impiegata principalmente in ruolo anti nave su bassi fondali, non provvista di ancora e cavo di ormeggio perchè posata sul fondo, è dotata di congegni di fuoco magnetici, acustici ed a pressione.
[76] Mine posate nel Mediterraneo – dati estratti da La Guerra di mine, opera citata, 1966.
| Mine ormeggiate | ||
| tipologia | ad urto o ad antenna | magnetiche |
| italiane | 17.000 | n.d. |
| tedesche | 9958 | 2266 |
[77] “La guerra di mine”, Ufficio Storico della Marina, vol. XVIII, ediz. 1988, pag. 217-238
[78] Amm. Sir Andrew Cunningham “A Sailor’s Odissey” Hutchinson, Londra, 1956
[79] “La guerra di mine”, Ufficio Storico della Marina, vol. XVIII, ediz. 1988 pag. 495 – nel periodo furono posate 972 mine da fondo ad influenza inglesi.
[80] Per eventuali approfondimenti sul sito www.regiamarina.net si possono trovare ulteriori dati sulle capacità offensive e difensive della Regia Marina nel periodo della guerra.
[81] Per completezza va menzionato che il Trattato di Pace firmato dall’Italia con gli Alleati tra le molte restrizioni, all’art. 51 impose il divieto di possedere mine ed altre armi subacquee.
- autore
- ultimi articoli
ammiraglio della Marina Militare Italiana (riserva), è laureato in Scienze Marittime della Difesa presso l’Università di Pisa ed in Scienze Politiche cum laude all’Università di Trieste. Analista di Maritime Security, collabora con numerosi Centri di studi e analisi geopolitici italiani ed internazionali. È docente di cartografia e geodesia applicata ai rilievi in mare presso l’I.S.S.D.. Nel 2019, ha ricevuto il Tridente d’oro dell’Accademia delle Scienze e Tecniche Subacquee per la divulgazione della cultura del mare. Fa parte del Comitato scientifico della Fondazione Atlantide e della Scuola internazionale Subacquei scientifici (ISSD – AIOSS).








































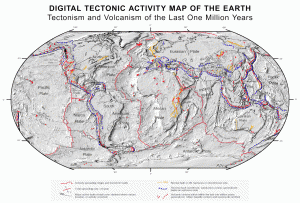























Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.