.
livello elementare
.
ARGOMENTO: STORIA NAVALE
PERIODO: V – III SECOLO a.C.
AREA: MEDITERRANEO
parole chiave: Cartagine, guerre puniche
–
Il secondo conflitto contro i Cartaginesi, con il suo grandioso scenario che abbracciava quasi l’intero Mediterraneo, dalle coste della Spagna al mare Egeo, fu la palestra nella quale i Romani misero a punto e sfruttarono intensivamente l’altra importante funzione dei classici milites, quella relativa al loro impiego per la “proiezione di forza” dal mare sulla terraferma: colpi di mano anfibi, operazioni di sbarco anfibio e anche operazioni protratte sulla costa o nell’entroterra. Si possono in effetti citare i reiterati sbarchi compiuti dagli Scipioni (padre e zio del più celebre Scipione) sulle coste iberiche e anche le protratte operazioni terrestri che seguirono la presa della base navale punica di Carthago Nova (odierna Cartagena, Spagna) da parte del giovane Scipione, il futuro “Africano”.

Marcia di Scipione (il futuro africano) da Tarraco a Nova Carthago in Spagna nel 210/209 a.C.
Dopo l’espugnazione della predetta città, avvenuta con un’operazione congiunta delle legioni, da terra, e dei classici milites, dal mare, si ebbe la prova del forte spirito di corpo che già animava questi ultimi: per l’assegnazione dell’onorificenza della corona murale, che spettava al primo militare che era salito sulle mura della città nemica, essi sostennero con tale ardore la candidatura del proprio commilitone, Sesto Digizio, contro quella di un ufficiale dell’esercito, il centurione Quinto Trebellio, che Scipione ritenne preferibile assegnare il premio ad entrambi, apparentemente convinto che vi fosse stata fra di loro un’assoluta parità. Egli era stato infatti consigliato in tal senso dal comandante della flotta, Lelio, poiché sembrava evidente che le due fazioni stessero per venire alle mani.

In quello stesso conflitto, le altre proiezioni di forza dal mare vennero effettuate: nel Mediterraneo orientale, con numerosi sbarchi e altre azioni contro costa per neutralizzare le mosse ostili di Filippo V re di Macedonia; nel Mediterraneo centrale, per la presa navale di Siracusa e quale concorso alla riconquista di Taranto; nelle acque africane, con reiterate incursioni navali sulle coste puniche. Questi colpi di mano finalizzati a devastare le coste nemiche e a mantenere il naviglio nemico impegnato in operazioni difensive, erano già stati sperimentati dai Romani durante la prima guerra Punica, quando essi avevano compiuto delle vere e proprie azioni corsare. Nel conflitto successivo, mentre Annibale aveva esaurito le proprie capacità offensive ed effettuava azioni inconcludenti nel sud Italia, una flotta di ben cento navi da guerra e due legioni di classici milites erano state assegnate al pretore Tito Otacilio Crasso per le incursioni sulla costa nordafricana. Tale informazione, unita ad altre analoghe fornite saltuariamente da Tito Livio, fa anche capire che una legione di marina poteva essere imbarcata su una cinquantina di navi, oppure su sole 35 unità se erano tutte quinqueremi.
.
La seconda guerra Punica si concluse, com’è noto, con lo sbarco in Africa di Scipione, che doveva costringere Cartagine alla resa e all’incendio della sua flotta. Questo felice epilogo non pose certamente fine agli impegni dei classici milites, poiché il dominio del mare acquisito dai Romani in conseguenza della vittoria navale delle Egadi aveva dato l’avvio alla loro espansione oltremare.

Aetas transmarina
Per dare il giusto rilievo a questa nuova situazione, basta considerare che i Romani avevano impiegato i precedenti cinque secoli di ininterrotte guerre terrestri per conseguire l’annessione del Lazio e l’egemonia sull’intera Penisola, mentre lo straordinario dinamismo navale della aetas transmarina consentì loro di espandere progressivamente la propria area d’influenza, il loro controllo o il loro dominio su tutte le sponde del Mediterraneo nell’arco di soli due secoli. Si trattò infatti di un’espansione avvenuta pressoché esclusivamente per via marittima, sfruttando il dominio del mare acquisito dai Romani e sistematicamente confermato nello sconfiggere, una dopo l’altra, tutte le maggiori ed esperte potenze navali del mondo ellenistico. In questa fase fondamentale della storia della repubblica e della civiltà romana, i classici milites furono utilizzati nell’intera gamma delle funzioni per essi già efficacemente sperimentate nelle prime due guerre puniche: in battaglia navale, l’utilizzo delle armi da getto individuali e delle grandi macchine belliche imbarcate, oltre alle azioni di arrembaggio e di cattura delle navi nemiche abbordate; in operazioni contro costa, il tiro navale contro postazioni costiere nemiche, il colpo di mano anfibio o l’assalto navale per lo sbarco di forze consistenti; sulla costa e nell’entroterra, le operazioni belliche terrestri coordinate con le azioni navali. Tutti questi impegni si sono verificati, in maggiore o minor misura, nella lunga e ininterrotta serie di guerre d’oltremare susseguitesi a partire dal termine della seconda guerra Punica fino alla vittoria navale di Azio, che segnò la fine dell’ultimo grande regno ellenistico potente sul mare e l’avvio, nel Mediterraneo, del periodo della pax Augusta e dell’Impero.
Fine IV parte
Domenico Carro
.
in anteprima spoglie navali tratte dalle navi nemiche vinte, per esibirle nel trionfo: prore rostrate e rostri, aplustri, acrostoli, ancore, remi, timoni e un pennone cui è assicurato un perfetto bozzello con i relativi cavi. Bassorilievi dell’arco onorario di Orange, l’antica Arausio – foto D’Amato
estratto dal saggio Classiari – Supplemento alla Rivista marittima aprile-maggio 2024 – per gentile concessione della Rivista Marittima dedicato alla memoria del figlio Marzio, corso Indomiti, informatico visionario e socio del Mensa, prematuramente scomparso
.
PAGINA PRINCIPALE - HOME PAGE
.
PARTE I PARTE II
PARTE III PARTE IV
.
Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo
.
- autore
- ultimi articoli
ammiraglio di divisione della Riserva della Marina Militare Italiana, dal momento del suo ritiro dal servizio attivo, assecondando la propria natura di appassionato cultore della Civiltà Romana, ha potuto dedicarsi interamente all’approfondimento dei suoi studi storiografici, nell’ambito dei quali ha pubblicato numerosi libri e saggi, creato l’interessantissimo sito ROMA AETERNA ed il foro di discussione FORVM ROMAETERNA (2001-2013), poi sostituito dall’istituzione di pagine estratte da “Roma Aeterna” nelle maggiori reti sociali, quali Linkedin, Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, etc. Non ultimo, l’ammiraglio Carro è relatore in importanti convegni, nazionali ed internazionali sui temi della storiografia romana e della salvaguardia della cultura marittima.































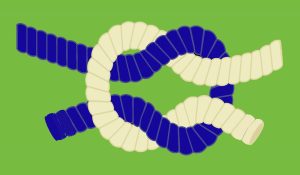
































Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.