.
livello elementare
.
ARGOMENTO: STORIA NAVALE
PERIODO: XVI SECOLO
AREA: MAR MEDITERRANEO
parole chiave: pirati barbareschi
La presenza dei corsari barbareschi (ossia dei navigli armati dalle Reggenze di Algeri, Tunisi e Tripoli per “correre il mare”) è una costante di lungo periodo nella storia del Mediterraneo.
Per oltre tre secoli, dal Cinquecento ai primi decenni dell’Ottocento, un numero sempre maggiore di stati europei hanno dovuto fare i conti con la spiacevole presenza di questi predatori marittimi (e il problema ha riguardato non solo gli stati europei, nell’Ottocento sarà la volta degli Stati Uniti). La minaccia barbaresca è stata dapprima un problema quasi esclusivo degli paesi mediterranei: nel Cinquecento la guerra di corsa barbaresca si è infatti intimamente legata al conflitto mediterraneo che ha per protagonisti l’Impero ottomano, la Spagna asburgica, coi suoi domini e i suoi alleati, e Venezia (con la Francia alleata degli ottomani ma sul mare, più che altro, spettatrice). Già in questa prima fase la difesa contro la minaccia barbaresca (che si manifestava sia come attività predatrice in mare e sia come incursioni razziatrici a terra) assume due forme principale:
– Militare: difesa delle coste e degli spazi marittimi attraverso fortificazioni e forze navali.
– Diplomatica: stipula di trattati di pace (una via praticata in primo luogo da Venezia, interessata a mantenere aperto il commercio col Levante Mediterraneo).
I corsari barbareschi furono marinai di religione musulmana – soprattutto nordafricani e ottomani, ma anche rinnegati – che, a partire dal Cinquecento fino al primo Ottocento, solcarono il Mediterraneo occidentale e le coste atlantiche dell’Europa e dell’Africa per predare navi e città delle nazioni cristiane. ll loro nome deriva dal fatto che i loro porti di partenza erano principalmente sulle coste dell’Africa settentrionale, un’area geografica conosciuta presso gli europei come Barberia o Stati Barbareschi, nomi derivati dal termine “berbero”, che indica gli abitanti autoctoni di quelle regioni.
A partire dal tardo Cinquecento la scena mediterranea si arricchisce però di nuovi protagonisti: arrivano gli inglesi e gli olandesi. Poi, nel corso del Seicento e del Settecento, sarà la volta di danesi e svedesi. Questi nuovi protagonisti devono da subito fare i conti con la minaccia rappresentata dai corsari barbareschi. Non sono, il problema inizia a toccare anche la Francia, che prima godeva della protezione garantita dall’alleanza con gli ottomani (in quanto le Reggenze erano parte dell’Impero). Ma nel Seicento le Reggenze si slegano sempre più dalla sovranità ottomana, la riconosco formalmente ma agiscono come stati indipendenti con una propria politica estera. Una politica estera funzionale alla guerra di corsa: mantenere una condizione di guerra con il maggior numero possibile di stati europei in modo da mettere i propri corsari in condizione di predare le navi di questi stati legittimamente (e anche, naturalmente, di compiere razzie lungo le coste di questi stati).
Le navi francesi diventano quindi prede buone quanto le altre. Nel corso del Seicento, quindi, il quadro internazionale muta e si complica. Non è più sufficiente essere in pace con l’impero ottomano per godere dell’immunità dagli attacchi dei corsari barbareschi; per gli stati europei diventa necessario rapportarsi con ciascuna delle tre Reggenze. Come? La soluzione più efficace risulta essere quella basata sul binomio deterrenza-diplomazia, adottata dapprima da inglesi francesi e olandesi e poi, via via, anche negli altri stati europei. Questa soluzione implica una strategia che possiede tratti comuni in tutti i casi, sia nel tempo che nello spazio. Ed è facile capire il perché: la sua efficacia è manifesta e quindi tutti la copiano, se hanno i mezzi per porla in atto.
In cosa consiste questa strategia?
Nel compiere un’azione di forza contro la capitale della Reggenza in questione per poi ottenere un trattato di pace (a cui, almeno inizialmente, si associa un tributo pagato annualmente dallo stato europeo alla Reggenza). Nel corso del Seicento così operano inglesi, olandesi e francesi. Squadre navali di queste tre potenze in momenti diversi attaccano e bombardano le capitali delle tre Reggenze ottenendo trattati di pace che garantiscono l’immunità dei loro bastimenti mercantili in cambio di un tributo annuo. Ho detto prima che per poter porre in atto questa strategia servono dei mezzi: il mezzo è lo strumento navale, ossia la capacità di bombardare dal mare la capitale della Reggenza e la minaccia, credibile, di reiterare l’azione se il trattato di pace verrà violato o non sarà rinnovato (i trattati erano “a tempo” e andavano rinnovati periodicamente).
Sono infatti frequenti i casi in cui una Reggenza latita nel momento di rinnovare un trattato di pace in scadenza, risolvendosi poi a cedere quando una squadra navale della potenza europea in questione si presenta di fronte alla sua capitale. È facile quindi capire perché siano stati gli inglesi, gli olandesi e i francesi a varare questa forma di risposta alla minaccia barbaresca. Erano gli unici, nel Seicento, in possesso della forza militare e della volontà politica necessaria per attuare una minaccia credibile nei confronti delle Reggenze (la Spagna aveva la forza militare ma mancava della volontà politica di accordarsi con stati musulmani, Venezia si muoveva in un diverso contesto).
Nel corso del Settecento e del primo Ottocento il numero degli stati europei in grado di adottare questa strategia è andato via via aumentando, sia per lo sviluppo delle flotte delle potenze navali non di primo piano, sia per il loro aumentato interesse per il Mediterraneo (è il caso di Svezia e Danimarca), sia per lo sviluppo delle marine dei piccoli stati europei, sia, infine, per il contemporaneo indebolimento delle forze navali barbaresche. Il regno di Sardegna, a cui si riferisce il documento che proponiamo, è stato uno degli ultimi Stati europei a mettere in pratica questa strategia. Strategia che è riassunta nei suoi tratti essenziali proprio nel documento, una relazione presentata al re sardo l’11 aprile 1817.
La relazione ci parla dell’avvenuto invio a Tunisi e Tripoli dei consoli designati dal Re. Sono quindi in vigore trattati di pace con queste due Reggenze. Ma la Segreteria per gli Affari Esteri ritiene opportuno effettuare alcune crociere dimostrative lungo le coste del Nord Africa per esercitare pressione sui “Dey” in modo da garantire che i trattati siano rispettati, ossia che i corsari barbareschi rispettino l’immunità delle navi battenti bandiera del regno di Sardegna. La relazione è molto chiara: “Le frequenti lettere dei consoli di Vostra Maestà presso i Dey di Tunisi e Tripoli mentre contengono le più soddisfacenti notizie riguardo i sentimenti pacifici di quelle Reggenze insistono però continuamente sulla necessità di far loro vedere frattanto qualche legno da guerra, per mantenerli ne’ suddetti sentimenti“.
Il tema era delicato per questioni di politica interna. La stragrande maggioranza dei bastimenti mercantili del Regno era ligure. La Liguria era stata annessa forzatamente nel 1815. Il re aveva quindi particolare interesse nel creare consenso fra i suoi nuovi sudditi: proteggere i marittimi liguri dalla minaccia barbaresca, una minaccia a cui erano stati esposti interrottamente per i tre secoli precedenti, era uno dei migliori modi per farlo. Il messaggio era semplice: “io vostro nuovo sovrano vi do quella protezione, da voi tanto ambita, che il precedente sovrano, la Repubblica di Genova, non è stata in grado di garantirvi per 300 anni. Il cambio di regime, quindi, vi conviene“.
Venne pertanto stabilito di affidare la missione di effettuare crociere dimostrative prima ad una corvetta e poi, successivamente, ad una fregata (e nel 1825, in risposta alla violazioni dell’immunità da parte dei corsari di Tripoli, si passerà della deterrenza all’azione dissuasiva: verrà inviata una spedizione navale a bombardare la città).
Prof. Emiliano Beri
NavLab – Laboratorio di Storia marittima e navale
CEPOC – Centro interuniversitario di studi “Le Polizie e il Controllo del Territorio”
DAFiSt – Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia Università degli studi di Genova Via Balbi 6 – 16126 Genova
Emiliano.Beri@unige.it
Fonte:
Archivio di Stato di Torino, Ministero della Guerra, Archivio di Marina, registro n. 349
in anteprima sciabecco barbaresco contro nave francese – Collezione Royal Museums Greenwich http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/12201 – autore Aert Anthonisz – Cornelis Bol – olio su legno
A French Ship and Barbary Pirates RMG BHC0709.tiff – Wikimedia Commons
Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo
,
PAGINA PRINCIPALE- autore
- ultimi articoli
Emiliano Beri si è laureato con lode in Storia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova. Nel 2011 vi ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Storia, discutendo una tesi sulle guerre di Corsica del medio Settecento. Dal 2012 al 2016 è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia e Geografia dell’Università di Genova. Negli anni accademici 2016-17 e 2017-18 ha insegnato Storia sociale nel corso di Laurea triennale in Storia e Storia militare nel corso di Laurea magistrale in Scienze Storiche della Scuola di Scienze Umanistiche dell’Università di Genova. Per l’anno accademico 2018-19 è stato docente aggregato di Storia militare nel corso di Laurea magistrale in Scienze storiche della stessa Scuola. A partire dall’anno accademico 2019-20 è docente aggregato sia di Storia militare che di Storia sociale.



























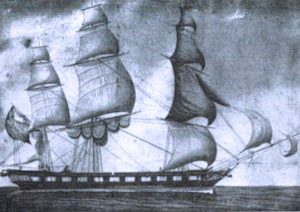





























sui barbareschi vorremmo tenere una conferenza al Museo Marineria di Viareggio
dobbiamo sapere condizioni per una sua venuta eventuale
Passero’ l’informazione all’autore, il professor Beri