.
livello elementare
.
ARGOMENTO: STORIA NAVALE
PERIODO: XVI SECOLO
AREA: MAR MEDITERRANEO
parole chiave: Lepanto, Lega Santa, Ottomani
.
La battaglia di Lepanto (7 ottobre 1571) è spesso etichettata come lo scontro decisivo che annientò la flotta ottomana e determinò la fine della superiorità marittima del Gran Turco e della sua espansione in Europa. Di più, in molti casi, sintetizzando, viene proposta un’interpretazione per cui, dopo Lepanto, il Gran Turco sostanzialmente avrebbe cessato di essere una minaccia nel Mediterraneo, tanto che, per dare nuovamente l’assalto all’Europa, fu costretto a tentare la via terrestre (l’assedio di Vienna, 1683).

Il Mediterraneo nel 1574, dopo la riconquista ottomana di Tunisi e la fine della guerra di Cipro (1570-73) e della guerra pluridecennale della Spagna contro l’Impero ottomano
Quale fu il vero valore della vittoria di Lepanto?
Per capire il valore strategico di Lepanto in primo luogo bisogna spiegare cos’è la strategia. Strategia è un termine che nel linguaggio comune viene usato molto spesso impropriamente e viene usato come sinonimo di tattica. In realtà tattica e strategia sono due rami differenti della sfera militare, e la strategia non può essere limitata alla sfera militare. La Tattica è l’arte di condurre il combattimento, ossia è l’arte di guidare un esercito o una flotta in battaglia. La Strategia è l’arte di utilizzare l’azione delle forze armate in funzione degli obiettivi politici della guerra; ossia di combattere e vincere battaglie che servano per raggiungere gli obiettivi che il proprio Stato persegue nella guerra. Solitamente la politica, il Governo, indica gli obiettivi delle guerre, e i militari devono pianificare e porre in atto il modo per ottenerli. Un generale o un ammiraglio può essere un grande tattico, ossia ottenere vittorie eccezionali in battaglia ma se le vittorie non servono a raggiungere gli obiettivi della guerra ecco che il generale o l’ammiraglio pecca come stratega.

La Réal di Don Giovanni d’Austria, ammiraglia della flotta della Lega Santa, e la Capitana di Sebastiano Venier, Capitano generale da Mar della Repubblica di Venezia – Arazzi di Lepanto, Palazzo del Principe, Genova (foto dell’autore)
Due guerre parallele
Ora che sappiamo che la strategia è l’anello di congiunzione tra battaglia e guerra, per capire Lepanto sotto il profilo strategico dobbiamo inquadrare la battaglia nella guerra in cui è stata combattuta; o meglio, nelle guerre in cui è stata combattuta, perché Lepanto è una battaglia che sta dentro a due guerre contemporanee tra loro, due guerre parallele.
La prima di queste due guerre è una guerra lunga, pluridecennale, combattuta dalla Spagna asburgica (e dai suoi domini e alleati italiani) contro l’Impero ottomano.
È una guerra combattuta dalla Spagna con un obiettivo primario specifico: il controllo del Nord Africa. Dopo la conclusione della Reconquista la Spagna aveva iniziato a subire le incursioni dei corsari nordafricani, corsari che erano per lo più mussulmani andalusi fuggiti in Nord Africa quando gli spagnoli (nello specifico i castigliani) avevano conquistato il Regno di Granada (1492), completando, appunto, la Reconquista della penisola iberica. Per eliminare il problema delle incursioni corsare la Spagna nel 1497 iniziò a conquistare le città portuali del Nord Africa. Entro il 1511 tutta la costa delle attuali Algeria, Tunisia e Libia erano sotto il dominio spagnolo. L’espansione spagnola in Nord Africa andò però a cozzare con quella ottomana. L’impero ottomano aveva conquistato l’Egitto nel 1517 e, dagli anni ’20, corsari nord africani (che resistevano all’espansione spagnola) avevano riconosciuto il Sultano ottomano come sovrano, ottenendone l’aiuto. Da questo momento il conflitto andò avanti con una serie di conquiste e riconquiste successive di città portuali nordafricane, con Algeri, Tunisi e Tripoli come obiettivi principali.

Le sei galeazze veneziane a Messina, porto di riunione della flotta della Lega Santa – Arazzi di Lepanto, Palazzo del Principe, Genova (foto dell’autore)
La seconda di queste due guerre è una guerra breve, combattuta tra Venezia e l’Impero ottomano per l’isola di Cipro
L’isola di Cipro, veneziana, era stata conquistata dagli Ottomani nel 1570 e Venezia, che era in pace con gli Ottomani da oltre trent’anni, per poterla recuperare cercò l’alleanza con la Spagna.

La Capitana della galeazze veneziane – Arazzi di Lepanto, Palazzo del Principe, Genova (foto dell’autore)
C’è un problema nel fatto che la battaglia di Lepanto si collochi in due guerre parallele. I due alleati vincitori della battaglia, Spagna e Venezia, avevano obiettivi di guerra strategici diversi. La Spagna puntava alla riconquista del Nord Africa, che in quel momento era quasi totalmente passato sotto dominio ottomano. Venezia voleva riconquistare Cipro. I due alleati quindi avrebbero dovuto sfruttare la vittoria per ottenere due obiettivi diversi, e divergenti. Come andò a finire? Vediamolo
Il Mediterraneo tra la vittoria di Lepanto e la perdita di Tunisi (1571-1574)
Analizziamo la situazione del Mediterraneo immediatamente dopo Lepanto, tra 1571 e 1574, per capire quali siano state le conseguenze di Lepanto. A Lepanto la flotta ottomana fu annientata. Perse circa 170 delle 220 galee impegnate in battaglia. Un risultato eccezionale; mai, negli ultimi secoli, in una battaglia mediterranea si erano scontrate due flotte così grandi. Quella della Lega Santa, cioè dell’alleanza anti-ottomana, era formata da 6 galeazze e 109 galee veneziane, 30 galee ispano-napoletane, 28 ispano-genovesi, 6 ispano-siciliane, 14 spagnole, 12 toscano-pontificie, 3 genovesi, 3 sabaude e 3 dell’Ordine di Malta … mai la flotta sconfitta aveva subito perdite così disastrose.

La Capitana di Genova (in alto) ammiraglia della flotta della Repubblica di Genova e la Capitana di Giovanni Andrea Doria (in basso), ammiraglia della squadra di galee di armatori genovesi al servizio della Spagna – Arazzi di Lepanto, Palazzo del Principe, Genova (foto dell’autore)
Come fu sfruttato l’annientamento della flotta ottomana nell’immediato; che obiettivi di guerra permise di raggiungere?
Nessun obiettivo perché la battaglia venne combattuta in ottobre. Nel tardo autunno e in inverno nel Mediterraneo si navigava poco e le operazioni navali, di guerra, venivano sospese per questioni climatiche e meteomarine. Così avvenne anche nel 1571 dopo la battaglia, per cui l’annientamento della flotta nell’immediato non venne sfruttato. Ma avrebbe potuto essere sfruttato nella primavera successiva, alla ripresa delle operazioni navali. La flotta ottomana era stata annientata, era impensabile che potesse venir ricostruita in tempi così brevi. Gli ammiragli spagnoli e veneziani erano sicuri che avrebbero avuto la via aperta verso Cipro nella primavera-estate del 1572.
Era però un’illusione
Un’illusione che lasciò presto lo spazio alla dura realtà: gli ottomani avevano ricostruito una grande flotta nello spazio di pochi mesi; un’operazione che spagnoli e veneziani reputavano impossibile. Si erano illusi di aver annientato in modo decisivo la flotta nemica, ma si disillusero davanti alla flotta che Ulugh Alì, il nuovo Gran Ammiraglio del Sultano, poté mettere in mare.
Arturo Pacini è chiaro in merito: «a cancellare l’euforia per la grande vittoria bastò l’armata turca di oltre 200 galee [160 galee e 40 unità minori secondo Guido Candiani, Dalla galea alla nave di linea, Città del silenzio, 2014, p. 20] che prese il mare già nel 1572. Si era tornati al punto di partenza; a meno di un anno di distanza da un disastro che l’Europa aveva giudicato e sperato assoluto e irreparabile per l’Impero ottomano, quest’ultimo era di nuovo, incontestabilmente, la maggiore potenza navale del Mediterraneo» (A. Pacini, Desde Rosas a Gaeta. La rotta spagnola del Mediterraneo occidentale nel secolo XVI, F. Angeli, 2013, p. 211).

La Capitana di Napoli, galea ammiraglia del Marchese di Santa Cruz, al centro della sua squadra – Arazzi di Lepanto, Palazzo del Principe, Genova (foto dell’autore)
Questa nuova grande flotta ottomana era inferiore qualitativamente a quella distrutta a Lepanto, ma la sua forza era sufficiente ed impedì, infatti, alla flotta della Lega di raggiungere Cipro. Il raggiungimento dell’obiettivo veneziano era fallito nuovamente. Venezia iniziò a trattare la pace con l’Impero ottomano, che si concluse nel 1573, e sancì la perdita di Cipro.
Anche la Spagna fallì nel perseguire i suoi obiettivi di guerra: la riconquista del Nord Africa. Nel 1573 la flotta spagnola puntò su Tunisi e la conquistò. Ma nel 1574, la flotta ottomana la riconquistò, senza che la Spagna potesse reagire. Nel 1576 la relazione dell’ambasciatore veneziano a Madrid sottolineò come la flotta spagnola, che in quel momento contava 130 galee, fosse troppo debole per contrastare quella ottomana. Due anni prima, nel 1574 la flotta spagnola aveva raggiunto l’apice della sua forza con centocinquanta 150 galee; non era mai stata, e non sarà mai, così forte. Ma in quello stesso anno la flotta ottomana aveva in mare 240 galee e 14 galeazze (gli ottomani avevano copiato le galeazze veneziane, ossia le unità che avevano avuto un ruolo tattico decisivo nella battaglia di Lepanto).

Battaglia di Lepanto: la mischia (1) – Arazzi di Lepanto, Palazzo del Principe, Genova (foto dell’autore)
Nel corso dei decenni successivi la Spagna decise ridimensionare la propria forza navale, perché i costi per mantenerla in servizio erano insostenibili, e da lì a poco iniziò a trattare un armistizio con gli ottomani, chiudendo quindi il conflitto per il dominio del Nord Africa a cui aveva dato il via nel 1497. Del suo estenso dominio nordafricano, quello che nel 1511 comprendeva le coste della attuali Algeria, Tunisia e Libia, gli restavano solo tre piccoli centri portuali minori, enclave in un Nord Africa finito, dall’Algeria all’Egitto, tutto sotto dominio ottomano (ad eccezione del Marocco, indipendente).

Battaglia di Lepanto: la mischia (2) – Arazzi di Lepanto, Palazzo del Principe, Genova (foto dell’autore)
Conclusioni
Le due guerre parallele, quella breve degli Ottomani con Venezia e quella lunga degli Ottomani contro la Spagna, si chiusero quindi dopo Lepanto con un sostanziale successo ottomano. Un successo probabilmente mitigato nelle dimensioni dalla sconfitta subita in battaglia a Lepanto; ma sempre di un successo si trattò. Gli Ottomani raggiunsero due degli obiettivi della loro politica di espansione: il Nord Africa e Cipro. Venezia e la Spagna fallirono negli obiettivi che si erano prefissati: Cipro e il Nord Africa.
La definitiva conquista ottomana del Nord Africa, in particolare, è un elemento che a livello geopolitico (ma non solo) ha determinato la configurazione del Mediterraneo per tutta l’età moderna. Il Mediterraneo a partire dal XVI secolo ha subito per tre secoli la minaccia della corsa barbaresca; una minaccia intensa, dominante, fino al tardo Seicento. In seguito, nel Settecento, la minaccia fu meno intensa sotto il profilo generale (perché le maggiori potenze europee avevano raggiunto accordi diplomatici con gli stati barbareschi); ma non meno intensa nel particolare degli Stati che non avevano potuto, o voluto, perseguire la via dell’accordo e quindi avevano dovuta subirla fino agli esordi dell’Ottocento.
L’origine di questo Mediterraneo percorso, in certi momenti quasi dominato, dai corsari barbareschi, sta nella conquista ottomana del Nord Africa nella contesa con la Spagna.
Lepanto non evitò che Venezia perdesse Cipro e la città di Dulcigno, porto albanese-montenegrino che Venezia cedette agli ottomani con la pace del 1573 e che diventò la principale base dei corsari operanti contro il traffico veneziano nell’Adriatico. Inoltre, non evitò che l’Impero ottomano vincesse la contesa con la Spagna per il Nord Africa, anzi questa contesa, che durava da decenni e in cui la Spagna aveva ottenuto non pochi successi, si chiuse appena tre anni dopo Lepanto con una vittoria ottomana (Tunisi 1574) e la rinuncia della Spagna a proseguire la guerra. La rinuncia della Spagna, con successiva ricerca di un armistizio con gli Ottomani, fece sì che la vittoria ottomana diventasse definitiva.
Emiliano Beri
Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo
,
- autore
- ultimi articoli
Emiliano Beri si è laureato con lode in Storia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova. Nel 2011 vi ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Storia, discutendo una tesi sulle guerre di Corsica del medio Settecento. Dal 2012 al 2016 è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia e Geografia dell’Università di Genova. Negli anni accademici 2016-17 e 2017-18 ha insegnato Storia sociale nel corso di Laurea triennale in Storia e Storia militare nel corso di Laurea magistrale in Scienze Storiche della Scuola di Scienze Umanistiche dell’Università di Genova. Per l’anno accademico 2018-19 è stato docente aggregato di Storia militare nel corso di Laurea magistrale in Scienze storiche della stessa Scuola. A partire dall’anno accademico 2019-20 è docente aggregato sia di Storia militare che di Storia sociale.




























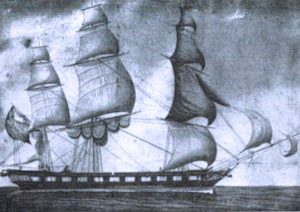








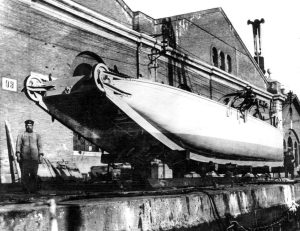


















Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.