.
livello elementare
.
ARGOMENTO: SUBACQUEA
PERIODO: XXI SECOLO
AREA: DIDATTICA
parole chiave: rebreather, circuiti chiusi
Oggi parliamo di rebreather, i moderni sistemi subacquei di respirazione autonoma a circuito chiuso divenuti sempre più popolari negli ultimi anni tra i subacquei più evoluti. Vorrei premettere che questa è un’introduzione a questi sistemi, che non può essere sicuramente esaustiva ma vuole dare qualche informazione generale su un campo complesso, sia dal punto di vista tecnico che di impiego di questi sistemi.
.

Breve storia
I sistemi respiratori a circuito chiuso nacquero in ambienti lavorativi terrestri come le miniere, impiegati dai Vigili del Fuoco che, per necessità operative, avevano necessità di disporre di una fonte d’aria respirabile dotata di un’elevata autonomia e peso ridotto. Nel tempo il loro uso si estese ai militari e al mondo ricreativo e scientifico.

l’invenzione del 1876 di Henry Fleuss
I moderni rebreather a miscela sono sotto un certo aspetto l’evoluzione dei primi sistemi ad ossigeno (Oxygen Rebreather), storicamente denominati ARO (acronimo per autorespiratore ad ossigeno), derivati dall’invenzione del 1876 di Henry Fleuss.
Questa apparecchiatura rivoluzionaria per il tempo, nata per soccorrere i minatori nelle miniere, fu poi sviluppata in campo militare quando se ne intravide un impiego importante per il personale intrappolato all’interno dei sommergibili sia in caso di emissione di gas di cloro dalle batterie sia in caso di abbandono del battello sinistrato. L’apparato di Robert Davis, DSEA (Davis Submerged Escape Apparatus) nacque nel 1910 proprio per questo scopo, al fine di consentire agli equipaggi dei sommergibili di fuoriuscire in sicurezza.
L’apparato consisteva in una sacca di respirazione in gomma contenente un contenitore di idrossido di bario, per ripulire la CO2 espirata, e all’estremità inferiore della sacca una bombola in acciaio che conteneva circa 56 litri di ossigeno ad una pressione di 120 bar. La bombola era dotata di una valvola di controllo ed era ovviamente collegata al sacco respiratorio. L’autonomia era di circa 30 minuti e avrebbe dovuto consentire ai militari di poter raggiungere la superficie.

l’apparato di Robert Davis
Il DSEA fu in seguito adottato dalla Royal Navy, dopo un ulteriore sviluppo di Davis, nel 1927. Ne derivarono vari rebreather industriali ad ossigeno come il Siebe Gorman Salvus e Siebe Gorman Proto, entrambi sviluppati nei primi anni del 1900.

Gamma italiani della X Mas
Forse l’uso che fece da battistrada al moderno impiego professionale fu il loro impiego da parte dei primi sommozzatori guastatori italiani (Gamma), grazie alla caratteristica non trascurabile di non emettere bolle, salvaguardando così la loro invisibilità, e la lunga autonomia ottenuta dalla rigenerazione dei gas respiratori. Tutto nacque negli anni ’30, quando i primi pescatori subacquei sportivi italiani iniziarono a usare il non sempre affidabile rebreather Davis; i produttori italiani acquisirono una licenza dai titolari di brevetti inglesi per produrre questi apparati in Italia.
Fu la Regia Marina italiana a svilupparne con successo l’uso bellico, con gli uomini Gamma della Decima Flottiglia MAS. Il resto come sapete è storia. Dopo la guerra eroi di guerra, come Luigi Ferraro, trasferirono le esperienze maturate nel campo civile e vennero sviluppati nuovi autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno (A.R.O). Il loro uso si allargò ad attività professionali e ricreative subacquee.

Come funzionano i rebreather?
Il principio di funzionamento dei rebreather è concettualmente identico in tutti i tipi i sistemi a circuito chiuso. Fondamentalmente questi sistemi consentono di assicurare al nostro organismo ossigeno per assicurare le funzioni metaboliche in maniera più efficiente.
Nei sistemi aperti, come i comuni autorespiratori ad aria (scuba) il subacqueo respira la miscela attraverso un erogatore che riceve l’aria da una bombola (tank) contenente gas in pressione. Essendo l’aria contenuta nella bombola ad alta pressione, essa deve essere ridotta attraverso degli stadi (primo e secondo) per poter essere respirata.
L’erogatore, o secondo stadio, ha invece la funzione di somministrare l’aria a richiesta al subacqueo. Ad ogni nostra profonda inspirazione deve seguire una altrettanto profonda espirazione, che rilascia nell’ambiente marino delle bolle. Questo sistema, tecnicamente semplice, non è efficiente in quanto ad ogni inspirazione immettiamo nei nostri polmoni una quantità di ossigeno ben oltre il nostro fabbisogno e quando espiriamo perdiamo una parte dell’ossigeno che potremmo invece riutilizzare allungando così la nostra autonomia.
Da qui la necessità di utilizzare i sistemi a circuito chiuso che, come leggeremo, ci consentono di allungare la nostra permanenza sott’acqua.
–

Principio di funzionamento di un rebreather
Questi sistemi recuperano parte del gas espirato, fissando la CO2 e recuperando l’ossigeno non utilizzato. Di conseguenza si ottiene un’autonomia maggiore a parità del gas contenuto nelle nostre bombole. Per poter recuperare e riutilizzare il gas espirato, è necessario fissare l’anidride carbonica (CO2 o biossido di carbonio), utilizzando un sistema filtrante detto scrubber.
 Molto semplicemente: il sistema utilizza un filtro, chiamato canister o capsula, che contiene una quantità discreta (circa un chilogrammo) di un composto chimico, la calce sodata, una mistura di idrossidi (calcio potassio e sodio) che ha la proprietà di fissare l’anidride carbonica che lo attraversa restituendo ossigeno. I prodotti più efficienti (chiamati genericamente assorbenti) sono venduti in forma granulare. La dimensione del granulo è generalmente valutata su una scala da 4 a 12, dove 4 è un granello grande e 12 è il minore. Spesso l’assorbente è disponibile in una gamma di dimensioni, ad esempio 4-8 o 8-12. Alcuni contenitori preconfezionati hanno altri numeri. Generalmente, i granuli più piccoli hanno una maggiore superficie e tendono ad essere più efficienti dei granuli più grandi, ma aumentano la resistenza respiratoria.
Molto semplicemente: il sistema utilizza un filtro, chiamato canister o capsula, che contiene una quantità discreta (circa un chilogrammo) di un composto chimico, la calce sodata, una mistura di idrossidi (calcio potassio e sodio) che ha la proprietà di fissare l’anidride carbonica che lo attraversa restituendo ossigeno. I prodotti più efficienti (chiamati genericamente assorbenti) sono venduti in forma granulare. La dimensione del granulo è generalmente valutata su una scala da 4 a 12, dove 4 è un granello grande e 12 è il minore. Spesso l’assorbente è disponibile in una gamma di dimensioni, ad esempio 4-8 o 8-12. Alcuni contenitori preconfezionati hanno altri numeri. Generalmente, i granuli più piccoli hanno una maggiore superficie e tendono ad essere più efficienti dei granuli più grandi, ma aumentano la resistenza respiratoria.

Un produttore di rebreather deve quindi valutare il giusto compromesso tra efficienza dello scrubber e resistenza respiratoria per scegliere quali impiegare in un particolare rebreather. Il materiale assorbente non è eterno e va naturalmente sostituito con attenzione ogni volta, seguendo le procedure previste. Senza entrare nei particolari, in alcune situazioni al posto della calce sodata si utilizzano delle altre molecole (acque fredde).
I rebreather hanno uno o due sacchi polmone, collegati al boccaglio per mezzo di tubi di grossa sezione (detti corrugati) attraverso i quali passa il gas espirato ed inspirato.
 Generalmente tra i due sacchi si trova il filtro di calce sodata. Va compreso che il gas espirato, pur contenendo ancora una certa percentuale di ossigeno, deve essere comunque miscelato con ossigeno o un’altra miscela respiratoria per poter continuare ad essere utilizzato. Il sistema impiegato per ripristinare la percentuale di ossigeno necessaria alla respirazione determina il principio di funzionamento del rebreather e rappresenta il fattore più importante e delicato dell’apparecchiatura.
Generalmente tra i due sacchi si trova il filtro di calce sodata. Va compreso che il gas espirato, pur contenendo ancora una certa percentuale di ossigeno, deve essere comunque miscelato con ossigeno o un’altra miscela respiratoria per poter continuare ad essere utilizzato. Il sistema impiegato per ripristinare la percentuale di ossigeno necessaria alla respirazione determina il principio di funzionamento del rebreather e rappresenta il fattore più importante e delicato dell’apparecchiatura.
Circuito chiuso o semichiuso? Quali sono le differenze?
I rebreather sono solitamente costituiti da un loop di respirazione (breathing loop) impiegato per la funzione vitale della respirazione. Il flusso della miscela respirata si muove solo in un senso.

Vediamone i componenti principali:
un boccaglio (mouth piece) collegato a due tubi di gomma corrugata, uno usato per l’inalazione e l’altro per l’espirazione, un sistema di fornitura di ossigeno (addizione) al loop, un sistema per il filtraggio dell’anidride carbonica dal loop (scrubber), una sacca morbida per contenere la miscela respiratoria. L’ossigeno aggiuntivo viene aggiunto al loop per sostituire quello metabolizzato dall’organismo tramite una bombola mentre l’anidride carbonica presente nel gas espirato, come abbiamo premesso, viene rimossa attraverso il filtro chimico (ad esempio la calce sodata).
Dato che la maggior parte del gas del loop rimane al suo interno, invece di essere espulsa sott’acqua come nei sistemi SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus), il rebreather risulta molto più efficiente dal punto di vista del consumo di gas e ci fornisce un’autonomia decisamente maggiore, ma non solo. In caso di lavori particolari, consente di non disturbare l’ambiente con le emissioni ed è quindi necessario per lo studio di determinate biodiversità.
 La grandezza dei sacchi è un aspetto critico del design di un rebreather; essi devono essere sufficientemente grandi per fornire il volume del gas che il sub inspira ed espira in un singolo atto respiratorio. Molti rebreather incorporano due sacchi nel breathing loop, uno di inspirazione e uno di espirazione. Dato che questi si espandono quando il sub espira, il volume totale (di galleggiamento) del sub rimane sempre costante. In altre parole, a differenza dei sistemi a circuito aperto SCUBA, tra la fase inspiratoria e quella espiratoria, l’assetto del subacqueo non cambia.
La grandezza dei sacchi è un aspetto critico del design di un rebreather; essi devono essere sufficientemente grandi per fornire il volume del gas che il sub inspira ed espira in un singolo atto respiratorio. Molti rebreather incorporano due sacchi nel breathing loop, uno di inspirazione e uno di espirazione. Dato che questi si espandono quando il sub espira, il volume totale (di galleggiamento) del sub rimane sempre costante. In altre parole, a differenza dei sistemi a circuito aperto SCUBA, tra la fase inspiratoria e quella espiratoria, l’assetto del subacqueo non cambia.
Genericamente parlando, ci sono due tipi di rebreather: a circuito semi-chiuso e a circuito chiuso.

sistema a circuito semi chiuso
Nel primo caso, il semichiuso, l’ossigeno è fornito mediante un continuo ricambio della miscela presente nel circuito respiratorio, pertanto una parte di essa viene dispersa nell’ambiente esterno. Come nei circuiti chiusi il biossido di carbonio prodotto dal metabolismo è eliminato dalla calce sodata. Esistono due sistemi per il ricambio della miscela: uno è detto a flusso continuo o alimentazione attiva, l’altro ad alimentazione passiva. Nel primo caso il ricambio della miscela del circuito respiratorio si realizza mediante un ugello che inietta un flusso continuo di gas proveniente dalla bombola; l’eventuale gas in eccesso è disperso nell’ambiente esterno da un’apposita valvola posta in genere sul sacco polmone di espirazione o comunque su un punto opportuno del circuito respiratorio. Negli apparati ad alimentazione passiva, PASCR (Passive Addiction Semi Closed Rebreather) ad ogni inspirazione, grazie ad un congegno meccanico, vi è una piccola espulsione di gas rimpiazzato da quello proveniente dalle bombole. Tutti e due sistemi sono alimentati da una o più bombole che vengono caricate con miscele preconfezionate (Nitrox o Trimix). Senza entrare nei particolari, nei sistemi semichiusi, l’aggiunta di O2 è regolata da una valvola a massa costante.
I sistemi a circuito chiuso

Nel caso dei rebreather a circuito chiuso (Closed Circuit Rebreather o CCR), il cui schema è illustrato nella figura a lato, essi si differenziano dai sistemi semichiusi principalmente per due ragioni: la prima è che il gas non è periodicamente ventilato fuori dal loop, eccetto che in risalita, la seconda perché la percentuale di ossigeno nel loop è dinamica, cioè cambia con la profondità. Sono inoltre caratterizzati dalla presenza di due bombole separate di O2 e di diluente (quest’ultimo può essere composto da diverse miscele come EANx, Heliox, trimix). L’aggiunta di O2 è regolata da un sistema elettronico collegato a dei sensori di ossigeno e ad una valvola di aggiunta dell’O2 stesso, controllata elettronicamente (o manualmente come back-up), invece di una valvola a massa costante come nei sistemi semichiusi.

R416 – Petrel DiveCan non-rMS Hybrid Setpoint Controller
L’aggiunta del diluente è un’operazione che può avvenire manualmente o in maniera automatica. Nel secondo caso è presente una valvola di addizione su un sacco che, quando questo collassa, si attiva aggiungendo diluente al loop. Il sistema elettronico ci fornisce molte informazioni dettagliate, specialmente se nel controller è implementato un sistema di decompressione in tempo reale. Il sub ha quindi la possibilità di selezionare un Set point, cioè un valore di pressione parziale dell’O2 di suo piacimento (di solito 1,3 o 1,4).
In alcuni sistemi questa operazione è possibile anche sott’acqua per aumentare l’efficienza della decompressione. Il punto critico è la monitorizzazione di questo set point, cioè del valore di PO2 prescelto. In molti rebreather è presente un secondo controller di back up. Sono questi i tipi di rebreather più complessi e richiedono più attenzione nel controllo della PO2 per mantenerla entro i limiti di sicurezza. Di contro sono quelli che ci danno i vantaggi maggiori rispetto ai sistemi semichiusi, perché hanno un consumo di gas molto minore mantenendo una PO2 costante, riducendo così i tempi di decompressione.
Per oggi ci fermiamo qui. Ci sarebbe ancora molto da dire ma torneremo presto.
.
.
.
Alcune delle foto presenti in questo blog sono prese dal web, pur rispettando la netiquette, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o chiedere di rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo
- autore
- ultimi articoli
è composta da oltre 60 collaboratori che lavorano in smart working, selezionati tra esperti di settore di diverse discipline. Hanno il compito di selezionare argomenti di particolare interesse, redigendo articoli basati su studi recenti. I contenuti degli stessi restano di responsabilità degli autori che sono ovviamente sempre citati. Eventuali quesiti possono essere inviati alla Redazione (infoocean4future@gmail.com) che, quando possibile, provvederà ad inoltrarli agli Autori.




































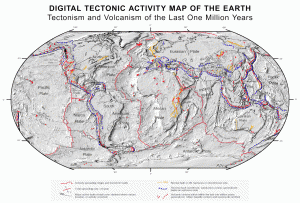





























Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.