.
livello elementare
.
ARGOMENTO: STORIA NAVALE
PERIODO: XX SECOLO
AREA: DIDATTICA
parole chiave: sommergibili, sottomarini, batiscafi
.
Impiego dei mezzi subacquei in campo civile
In questa carrellata sulle tipologie dei mezzi subacquei vanno menzionati quelli che furono (e sono tutt’oggi) impiegati in molti settori della vita civile. Il loro sviluppo è stato esponenziale e si è assistito, in campo civile, un impiego molto più ampio dei mezzi subacquei arrivando a soluzioni, come con gli UUV, che non necessitano la presenza fisica dell’Uomo per la loro guida. Ma andiamo per ordine.
Storicamente vanno menzionati i Batiscafi o Batisfere, sommergibili studiati per poter immergersi a grandi profondità ma con limitate capacità di movimento. Le prime batisfere non possedevano una capacità di propulsione autonoma e necessitavano di una nave madre che li guidasse nelle loro missioni. Esse furono utilizzate sia per scopi militari che nel campo civile nella ricerca scientifica. Il primo mezzo studiato per la ricerca fu il C3, un batiscafo artigianale progettato dall’italiano Pietro Vassena nel 1948. Il mezzo, il 12 marzo 1948, al largo di Argegno, scese alla profondità di 412 metri, stabilendo così il record mondiale di massima profondità raggiunta. Ma non fu utilizzato a lungo: il 20 novembre 1948 il C3, durante un primo tentativo di discesa a 948 metri senza equipaggio, a causa di un guasto al verricello s’inabissò nelle acque al largo dell’isola di Capri e non fu mai recuperato. Il primo batiscafo, sviluppato per immersioni marine e con una maggiore capacità di propulsione, fu l’FNRS-2, costruito in Belgio da Auguste Piccard. In seguito venne costruito dai cantieri navali di Monfalcone, dalle acciaierie Terni e infine assemblato a Castellamare di Stabia, il celebre Trieste I.
Fu proprio il Trieste I, con a bordo Jacques Piccard (figlio di Auguste), a stabilire il record mondiale di profondità in immersione, ancora oggi imbattuto, raggiungendo il fondo del cosiddetto Challenger Deep ovvero a 10917 metri nel punto più profondo della fossa delle Marianne, la maggiore profondità marina esistente. Il batiscafo Trieste misurava 18 metri in lunghezza, 3,50 in larghezza e il suo dislocamento normale era di 150 tonnellate. Lo scafo era di forma cilindrica e conteneva All’interno del cilindro erano ricavati 6 serbatoi di cui quattro venivano riempiti con benzina avio che fungeva da liquido idrostatico. La benzina, essendo più leggera dell’acqua, avrebbe fornito al Trieste una spinta positiva. Per immergersi, poteva invece imbarcare acqua negli altri due serbatoi. All’interno era ricavato un tunnel che conduceva fino all’abitacolo sferico sottostante, una sfera di acciaio fusa in un solo pezzo perché doveva essere completamente priva di disomogeneità in quanto una minima falla, alle profondità che dovevano essere raggiunte, avrebbe portato all’implosione della sfera.
Alle 13:06 del 23 gennaio 1960, dopo 4 ore e 48 minuti dall’immersione, i fari al quarzo del batiscafo illuminarono per la prima volta il fondo marino dell’abisso. Attraverso l’oblò realizzato in un unico blocco conico di plexiglas, i due membri dell’equipaggio (Don Walsh e Jacques Piccard, figlio del costruttore) scorsero un pesce evidentemente attratto dall’inusuale sorgente di luce. A quella profondità, il batiscafo Trieste, fu sottoposto ad una pressione di 1,17 tonnellate su centimetro quadrato, pari a circa mille volte quella atmosferica. Un impresa eccezionale considerando che, dopo il Trieste, solo tre batiscafi hanno raggiunto le profondità della fossa delle Marianne:
- il Kaiko (senza equipaggio), nel 1995 (lo scafo si perse in mare durante una missione nel 2003);
- il Nereus (senza equipaggio), nel 2009;
- il batiscafo Deepsea Challenger pilotato da James Cameron nel marzo del 2012.
Nel 1984, Piccard si immerse anche in Italia, con un altro batiscafo, il Forel, nelle profondità del lago di Albano. Questo lago, sito a sud di Roma, è considerato il lago vulcanico più profondo d’Europa. Lo scopo fu la ricerca di resti archeologici e la raccolta di dati chimico–fisici sulla distribuzione dei gas disciolti nell’acqua, in particolare dell’elio considerato un importante indicatore di eventi sismici. Il Forel raccolse molti dati e fece delle misure di gravità più precise di quelle effettuabili dalla superficie. Inoltre, i prelievi di sedimenti e di campioni di acqua permisero di conoscere meglio le caratteristiche dei microrganismi e di tutta la flora e la fauna presenti nel lago.
Il 2 agosto 2007, due batiscafi russi, il Mir-1 e il Mir -2 sono arrivati a 4.302 metri di profondità toccando il fondo marino del Polo Nord. Tale immersione rientrava nelle campagne di ricerca, attualmente ancora in corso, di nuovi giacimenti di idrocarburi. Appena un’ora più tardi riaffiorarono in superficie dopo aver piantato sul fondale un vessillo bianco, blu e rosso, con i colori della Russia. In realtà lo scopo ultimo dell’impresa fu di cercare di provare che la superficie sottomarina fosse direttamente collegata alla piattaforma continentale russa attraverso la dorsale Lomonov, un’enorme propaggine rocciosa che si protende sul fondo del mar Glaciale Artico collegando la Piattaforma di Lincoln, al largo della costa canadese con la Piattaforma siberiana. Il motivo è ovviamente politico ed economico.
Se fosse dimostrata la tesi russa, Mosca potrebbe rivendicare la piena sovranità su un’estensione di 1,2 milioni di chilometri quadrati, considerata una riserva di idrocarburi dall’inestimabile valore economico ed energetico. Vi si troverebbero infatti un quarto delle riserve mondiali di gas e petrolio per un totale di dieci miliardi di tonnellate di idrocarburi nonché minerali pregiati come stagno, manganese, oro, nichel, piombo, platino e … diamanti. Ma questa è un’altra storia.
Per opportuna completezza, voglio ricordare anche l’unico minisottomarino a propulsione nucleare esistito (o almeno di cui si è a conoscenza): l’NR 1. Questo battello, di piccole dimensioni, venne utilizzato dalla Marina statunitense fino al 2008, ufficialmente per scopi oceanografici e ricerche di natura civile. Per le sue caratteristiche particolari, tra cui un sistema di propulsione su cingoli quando appoggiato sul fondo del mare, venne impiegato anche da Ballard durante la ricerca di artefatti e relitti su alti fondali.
L’NR 1 fu costruito nel 1969 nel cantiere della General Dynamics di Groton, e nonostante fosse stato progettato per la ricerca scientifica oceanografica, il recupero di oggetti e per l’installazione di apparecchiature subacquee, le sue attività operative furono sempre coperte dal segreto. In pratica il mezzo fu gestito quasi sempre dalla Marina con compiti mai del tutto chiariti. Con una lunghezza di 140 piedi per 400 tonnellate di dislocamento, l’NR 1 fu il sottomarino nucleare più piccolo mai messo in servizio. Alimentato da una centrale nucleare miniaturizzata, costruita su misura, il Nerwin, come veniva chiamato dal suo equipaggio, poteva raggiungere una velocità massima di circa quattro nodi ed immergersi a 3000 piedi (circa 1000 metri). L’NR 1 aveva tre oblò per la visione frontale e verso il basso, con 25 luci esterne, telecamere a basso livello di luce (LLL), una videocamera a colori, una fotocamera elettronica (ESC) ed altri ausili visivi. Era dotato di sensori per la raccolta di dati ambientali e la registrazione dei dati scientifici. Inoltre, era dotato di una varietà di sonar differenti come un Obstacle Avoidance Sonar (per procedere in condizioni di assoluta torbidità) ed un Side-Looking Sonar (SLS) utilizzato per mappare il fondo e ricercare oggetti (fu usato anche per la ricerca ed identificazione dei resti dello Space Shuttle Challenger nel 1986). Come premesso nel 1995, il Dr. Robert Ballard impiegò l’NR 1 per esplorare il relitto del Britannic, sister ship del Titanic, che affondò nel Mar Egeo durante la prima guerra mondiale.
fine terza parte
andrea mucedola
.
in anteprima il batiscafo Trieste, un veicolo sommergibile di ricerca per immersioni profonde di costruzione italiana, che con il suo equipaggio di due persone raggiunse il 23 gennaio 1960 una profondità massima record di circa 10.911 metri (35.797 piedi), nella prima discesa della parte più profonda conosciuta degli oceani terrestri, nella Fossa delle Marianne vicino a Guam nel Pacifico. Nella foto il batiscafo è issato fuori dall’acqua subito dopo la sua acquisizione da parte della Marina degli Stati Uniti, intorno al 1958-59. Il battello è costituito da un recipiente a pressione sferico in acciaio di due metri di diametro che costituisce la cabina per le due persone di equipaggio. Per resistere all’estrema pressione il recipiente era sospeso sotto un grande serbatoio di benzina. La benzina, essendo più leggera dell’acqua, rendeva il battello capace di galleggiare, mentre, grazie alla sua incomprimibilità, forniva una resistenza alla pressione dell’acqua circostante senza richiedere l’impiego di un più un pesante recipiente a pressione. Estratto da NH 96801 U.S. Navy Bathyscaphe Trieste (1958-1963), collezione d’arte, U.S. Naval History and Heritage Command website. Rilasciato da U.S. Navy Electronics Laboratory, San Diego, California.
Bathyscaphe Trieste.jpg – Wikimedia Commons
Alcune delle foto presenti in questo blog sono prese dal web, pur rispettando la netiquette, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o chiedere di rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo
.
PAGINA PRINCIPALE - HOME PAGE
.
- autore
- ultimi articoli
ammiraglio della Marina Militare Italiana (riserva), è laureato in Scienze Marittime della Difesa presso l’Università di Pisa ed in Scienze Politiche cum laude all’Università di Trieste. Analista di Maritime Security, collabora con numerosi Centri di studi e analisi geopolitici italiani ed internazionali. È docente di cartografia e geodesia applicata ai rilievi in mare presso l’I.S.S.D.. Nel 2019, ha ricevuto il Tridente d’oro dell’Accademia delle Scienze e Tecniche Subacquee per la divulgazione della cultura del mare. Fa parte del Comitato scientifico della Fondazione Atlantide e della Scuola internazionale Subacquei scientifici (ISSD – AIOSS).

























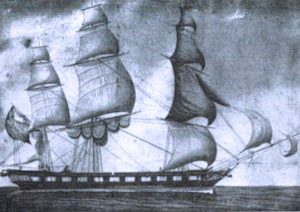





























Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.