.
livello elementare.
ARGOMENTO: RECENSIONE
PERIODO: I SECOLO AVANTI CRISTO
AREA: DIDATTICA
parole chiave: Eneide
Dopo aver raccontato i due massimi poemi classici di Omero, l’Iliade e l’Odissea, non possiamo non riassumere anche l’Eneide, il poema epico di Virgilio in cui il sommo poeta seppe mettere le basi al culto di Roma e, soprattutto, alla romanità che sopravvisse anche dopo la caduta dell’Impero. Nei secoli a seguire, l’eredità di Virgilio ebbe infatti una profondissima influenza sulla letteratura e sugli autori occidentali, in particolare su Dante Alighieri che, nella Divina Commedia, lo presceglie come guida durante il suo viaggio spirituale attraverso l’Inferno ed il Purgatorio.
La vita
Virgilio nasce a Mantova il 15 ottobre 70 a.C. da una famiglia di coloni romani, benestante ma non nobile, che si dedica all’apicultura e ai lavori bucolici. Dopo avere frequentato la scuola di grammatica a Cremona, si trasferisce a quella di filosofia a Napoli, dove si avvicina alla corrente filosofica epicureista e infine alla alla scuola di retorica di Epidio a Roma, un maestro importante di quell’epoca, per accedere alla carriera di avvocato, necessaria per la conquista delle cariche politiche. Di fatto la sua natura mite e riservata lo rendeva non adatto a parlare in pubblico e questo lo portò rivalutare i suoi progetti. Sono anni complessi per Roma, che vedono il passaggio tormentato dalla Repubblica all’Impero, attraverso le guerre civili, l’uccisione di Caio Giulio Cesare (44 a.C.) da parte di congiurati, e lo scontro tra due personaggi molto diversi, Ottaviano e Marco Antonio contro Bruto e Cassio, i capi dei Cesaricidi, uno scontro tra Romani che si concluderà con la battaglia di Filippi (42 a.C.). Ed è in quell’anno che Virgilio, non ancora trentenne, si trasferisce, a Napoli, per recarsi alla scuola dei filosofi Filodemo di Gadara e Sirone per apprendere i precetti di Epicuro. Anni in cui rischia di perdere le sue terre di famiglia, concesse ai veterani. Sarà solo grazie alle amicizie romane, tra cui il potente Mecenate, che Virgilio, riuscirà ad avere un podere in Campania come compensazione per le proprietà perdute nel suo villaggio di nascita.
Fu proprio in Campania che Virgilio terminerà la prima delle sue opere principali, le Bucoliche, e comporrà le Georgiche, dedicate al potente amico Mecenate. Nel 29 a. C., nella sua abitazione campana, il poeta ospita Ottaviano che è di ritorno dalla spedizione militare vittoriosa di Azio contro Marco Antonio e Cleopatra. Virgilio, con l’aiuto di Mecenate, legge ad Augusto il suo componimento poetico, “Le Georgiche” e diventa così uno dei poeti prediletti dell’uomo più potente di Roma e di tutto l’Impero romano. Tra il 29 a.C. e il 19 a.C., Virgilio scrive l’Eneide suddiviso in dodici libri. Un’opera monumentale che voleva essere il libro ufficiale all’ideologia del regime di Augusto sancendo l’origine e la natura divina del potere imperiale. Virgilio utilizza come modello le opere di Omero, in particolare l’Iliade, che idealmente prosegue narrando la storia di Enea, esule da Ilio che sarebbe diventato così il fondatore della divina gens Iulia a cui apparteneva Ottaviano poi divenuto Augusto.
Un’opera che non soddisfò il poeta al punto che prima di partire per l’Oriente ne avesse chiesto la distruzione, vietandone la diffusione in caso di sua morte. Virgilio, di ritorno da un viaggio in Grecia, morì a Brindisi il 21 settembre del 19 a.C., ma le sue volontà non furono rispettate dai suoi compagni di studio Plozio Tucca e Vario Rufo. Il manoscritto, tra l’altro incompleto fu consegnato ad Augusto che lo pubblicò, trasformandolo nel poema nazionale romano.
La grandezza dell’Eneide
Il poema narra le origini mitiche di Roma, non senza qualche incongruenza e piccole contraddizioni, ma che viene giustamente considerato il più rappresentativo dell’epica latina. L’Eneide racconta la leggendaria storia di Enea, un principe troiano fuggito dalla distruzione da parte degli Achei della sua città, che dopo molte peripezie arriva esule in Italia, diventando il precursore del popolo romano.
Enea è un eroe particolare, niente a che vedere con l’astuto Ulisse o l’iracondo Achille omerici, che viene definito, non a caso, pio. In lui troviamo il pragmatismo dell’antica Roma, maturo e responsabile, eletto dagli dei a cui si assoggetta al volere, rispettoso della famiglia e del padre Anchise che porta via sulle sue spalle da Troia, pieno di premure verso il giovane figlio Ascanio, sincero e corretto nei rapporti umani ma che non nasconde le sue debolezze, incertezze e dubbi.

Enea ritratto da Guido Reni, Busto di guerriero, 1620-1630, collezione privata
Enea è il modello della romanità augustea, dell’Uomo nuovo caratterizzato da coraggio, lealtà verso i simili e le autorità, clemenza verso i nemici, devozione verso gli dei, pazienza ed elevato senso civico. Valori che, se li avessimo conservati, avrebbero reso migliore la nostra storia passata e presente.
Come Omero nell’Iliade e nell’Odissea, Virgilio apre la sua opera con un proemio con lo scopo di anticipare il contenuto del poema.
“ … Canto le armi e l’eroe che per primo dai lidi di Troia giunse profugo per volere del fato in Italia e alle spiagge di Lavinio, sballottato a lungo per terre e per mare per la volontà degli dei, per l’ira ostinata della crudele Giunone, patendo molte sventure anche in guerra, finché fondò una città e stabilì nel Lazio i Penati, origine gloriosa della stirpe latina e albana e delle mura della gloriosa Roma … “
Dovendo confermare l’autorità di Caio Giulio Cesare, del figlio adottivo Augusto e dei suoi discendenti, Ascanio, figlio di Enea, viene rinominato Iulo e definito antenato della gens Iulia, la famiglia di Caio Giulio Cesare. Il messaggio che viene sottolineato è l’importanza della pietas, che secondo Augusto doveva essere la qualità più importante di ogni cittadino romano, che si esplica attraverso obblighi morali verso gli dei, la patria, i propri amici e la propria famiglia. Un messaggio che faciliterà, nei secoli seguenti, un’interpretazione cristiana dell’opera di Virgilio.
La storia
Le gesta di Enea, figlio di Anchise e della dea Venere, quindi anche lui un semidio come Achille, dopo lunghi viaggi e guerre, arriva sulle spiagge del Lazio dove metterà il seme della futura gens latina. Il poema scritto da Virgilio è diviso in dodici libri. I primi sei, sono fortemente ispirati all’Odissea, narrando i viaggi dell’eroe; i rimanenti sono invece modellati sull’Iliade, trattando le prime guerre tra gli esuli troiani e le popolazioni italiche. Ecco in breve il suo racconto.
Dopo sette anni di peregrinazioni Enea giunge al largo della costa africana. Come Ulisse non tutti gli dei lo amano, e Giunone, sua nemica, ordina a Eolo di scatenare una tempesta per far affondare le navi troiane. Ma Enea ha un protettore potente, Nettuno, che gli permette di sbarcare sulla spiaggia, dove la madre, Venere, assumendo le sembianze di una fanciulla, e lo invita a proseguire verso la città di Cartagine, fondata dalla regina Didone.
Didone è molto bella e vedova del marito Sicheo, ucciso dal fratello re di Tiro. Sotto un certo aspetto sono entrambi esuli che fuggono in altre terre per trovare una nuova vita. Didone li accoglie con benevolenza e, durante un banchetto, chiede all’eroe troiano di raccontare la distruzione di Troia e l’inganno del cavallo di legno. La storia, che non viene raccontata nell’Iliade, la conosciamo: i soldati achei capitanati da Odisseo/Ulisse penetrano attraverso il cavallo all’interno della città e, nella notte, fuoriescono ed aprono le porte della città al resto dell’esercito acheo. Ne consegue una strage, Troia viene bruciata, moltissimi cittadini uccisi.
Enea, portando con sé il padre Anchise, il figlio Ascanio ed alcuni compagni fugge attraverso la Tracia, le isole Strofadi dove incontrano le terribili arpie fino a Creta dove un oracolo gli raccomanda di tornare nell’antica madre, l’Italia, patria di Dardano. Enea parte con la sua nave costeggiando la Grecia fino alla Sicilia dove morirà il vecchio padre. Il racconto è ricco di pathos e tra Didone ed Enea nasce l’amore. Ma gli dei non sono dello stesso parere perché vogliono che la futura civiltà che dominerà il mondo sia altrove e non in Africa (e non avrebbe potuto essere diverso per giustificare la genesi di Roma). Giove ordina quindi ad Enea di ripartire, abbandonando la povera Didone. La regina non regge al dolore e, prima di togliersi la vita, maledice Enea, invocando eterna inimicizia tra i loro discendenti, di fatto mettendo le basi all’inimicizia tra Roma e Cartagine che porterà alla Seconda guerra punica.

Enea ritorna in Sicilia dove celebra la memoria del padre, e si spinge quindi nella penisola. Come Odisseo/Ulisse, guidato però dalla Sibilla, scende negli Inferi per incontrare l’anima del padre. Anchise gli profetizza la futura storia di Roma, mostrando le anime destinate a incarnarsi tra i grandi guerrieri e politici romani.
Sbarcato lungo le coste laziali Enea scopre che le terre sono governate dal re Latino (da cui i Latini), che vuole dare in sposa ad Enea la figlia Lavinia. Il problema è che Lavinia è già promessa a Turno, re dei Rutuli. Una situazione esplosiva e la dea Giunone manda la furia Aletto a scatenare la guerra tra Troiani e Latini, facendo uccidere da Ascanio il cervo della latina Silvia … e questo basta per scatenare le ostilità.
Grazie al consiglio del dio Tiberino, Enea raggiunge il greco Evandro, che ha fondato una colonia sul Palatino. Venere chiede al dio Vulcano di fabbricare le armi per Enea. In particolare sul suo scudo, viene scolpita la futura storia di Roma fino ad Augusto. Nel frattempo Turno, per ordine di Giunone, sferra un assalto per bruciare le navi dei Troiani. Sono pagine molto belle, in cui scopriamo nuovi personaggi come Eurialo e Niso che, dopo essersi battuti valorosamente, vengono alla fine sopraffatti. Niso muore nel tentativo vano di salvare l’amico. Il parallelismo alle vicende di Achille è evidente.
Alla fine Turno viene respinto e si salva a stento nel Tevere. La situazione diventa esplosiva e Giove, tra un tuono e l’altro, vieta agli dei di intervenire nella guerra. Intanto Enea ha trovato alleati negli Etruschi, che arrivano dal mare a bordo delle loro navi. Turno cerca di impedire lo sbarco con una violenta battaglia, e sfida Pallante, figlio di Evandro, uccidendolo. A questo punto Enea cerca Turno per vendicare la morte del giovane. Le lotte sanguinose terminano per seppellire i morti ed Enea, esempio della giustizia che sarà romana, offre la pace. Sebbene molti Latini credano sia la volontà degli dei, Turno vuole ancora combattere e si riaccende la battaglia.

Enea ferito – affresco da Pompeii, Casa di Sirico – l’eroe in piedi, viene curato dal medico Japix, mentre Venere, preoccupata, giunge portando erbe medicamentose; intanto il figlio Ascanio, in lacrime, è presso il padre, seconda metà del I sec. d.C. Napoli, Museo Archeologico nazionale – autore JoJanRimini219.jpg – Wikimedia Commons
Turno chiede di risolvere la guerra con un duello ed Enea accetta, ma Giuturna, sorella di Turno, induce i contendenti ad nuova battaglia sotto le mura di Laurento. A questo punto Giove e Giunone si accordano: Enea vivrà nel Lazio, sposando Lavinia, ed il suo popolo dovrà diventare uno solo con i Latini. Turno combatte in un duello finale con Enea e viene ferito. Enea però non lo risparmia riconoscendo le armi del giovane Pallante.
Finisce così l’Eneide scritta da Virgilio; manca la parte dove Enea sposa Lavinia e si riappacifica con gli Italici, stabilendosi nel Lazio mettendo le basi di Roma. Termina sotto un certo aspetto incompleta e lo sarà per molto tempo, fino al XV secolo, quando il poeta Maffeo Vegio comporrà in esametri il Supplementum Aeneidos, cioè il tredicesimo libro a completamento della vicenda narrata da Virgilio, trattando il matrimonio con Lavinia e l’apoteosi di Enea.
Andrea Mucedola
in anteprima la fuga di Enea, Galleria Borghese, Roma – autore Federico Barocci (1535–1612) Aeneas’ Flight from Troy by Federico Barocci.jpg – Wikimedia Commons
Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo
PAGINA PRINCIPALE
- autore
- ultimi articoli
ammiraglio della Marina Militare Italiana (riserva), è laureato in Scienze Marittime della Difesa presso l’Università di Pisa ed in Scienze Politiche cum laude all’Università di Trieste. Analista di Maritime Security, collabora con numerosi Centri di studi e analisi geopolitici italiani ed internazionali. È docente di cartografia e geodesia applicata ai rilievi in mare presso l’I.S.S.D.. Nel 2019, ha ricevuto il Tridente d’oro dell’Accademia delle Scienze e Tecniche Subacquee per la divulgazione della cultura del mare. Fa parte del Comitato scientifico della Fondazione Atlantide e della Scuola internazionale Subacquei scientifici (ISSD – AIOSS).

























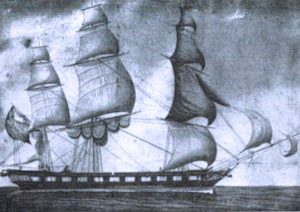





























Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.