.
livello elementare.
ARGOMENTO: GEOPOLITICA
PERIODO: XX-XXI SECOLO
AREA: MONDO
parole chiave: superpotenze, USA, Unione Sovietica
Sentiamo parlare spesso di guerra fredda, uno dei capitoli storici più discussi della politica internazionale. Sebbene sia inquadrata nel secolo scorso, dalla fine della seconda guerra mondiale al collasso dell’Unione sovietica (1990), alcuni analisti geopolitici ritengono che in realtà non sia mai veramente finita ma sia restata dormiente nei cassetti delle Superpotenze per far sentire nuovamente la sua pericolosità nei giorni nostri.
Memorie della guerra fredda
Il termine fu usato per la prima volta dallo scrittore George Orwell, il 19 ottobre 1945 in un articolo sul quotidiano britannico Tribune, descrivendo quel momento storico che tutti vivevano, in qualche modo, all’ombra della minaccia di una guerra nucleare fra i due blocchi.

La domanda che possiamo porci è che cosa accadde di così grave per trasformare due Paesi, di fatto alleati nella lotta contro le potenze dell’Asse, in nemici mortali. Proverò in questo breve articolo a dare una risposta, evitando i luoghi comuni.
Prima della guerra fredda, il sistema mondiale era multipolare, dove le potenze si scontravano da secoli per i propri giochi di potere. Quello che li unì fu la constatazione che gli interessi comuni, soprattutto economici, sarebbero stati sconvolti se i regimi totalitari europei avessero preso il sopravvento. Nonostante le profonde diversità di pensiero che li caratterizzava, i Paesi si unirono per combattere le potenze dell’Asse in un teatro che divenne presto mondiale. Nonostante i momenti drammatici, che portarono l’Europa da entrambe le parti al lumicino, fu l’impatto industriale degli Stati Uniti a fare la differenza. Lontani dalla guerra, l’industria statunitense continuò a produrre armamenti a ritmo continuo e ad inviare i suoi militari in tutti i teatri. Si arrivò così alla fine della guerra in Europa, con l’inevitabile caduta delle forze dell’Asse schiacciate da Ovest e da Est dagli Alleati che, nonostante le già evidenti diversità ideologiche, mantennero coerentemente fino alla fine il loro impegno bellico. Al termine della guerra, i nodi vennero al pettine e si generò un conflitto ideologico tra l’Occidente capitalista e l‘Unione Sovietica comunista che per oltre 40 anni non lesinò crisi e conflitti su scala globale.

Yalta (4 – 11 febbraio 1945)
Nel 1945 a Livadija, in Crimea, nella residenza estiva dell’ultimo zar di Russia, Nicola II, si tenne la Conferenza di Yalta, il più famoso degli incontri fra Stalin, Churchill e Roosevelt, i massimi rappresentanti delle grandi potenze alleate, che si erano già incontrati con la Conferenza di Teheran (28 novembre – 1º dicembre 1943). A Yalta si misero le basi per stabilire un futuro assetto politico al termine della Seconda guerra mondiale con la suddivisione del mondo in zone d’influenza. Nella conferenza furono stabiliti i nuovi confini tra Polonia e Germania e la suddivisione del territorio tedesco in quattro zone di occupazione, amministrate dalle tre potenze vincitrici (a cui si sarebbe poi aggiunta la Francia). Anche Berlino, di fatto inclusa nell’area occupata dai Sovietici, fu divisa in quattro settori: statunitense, britannico e francese, poi conosciuti come Berlino Ovest, che formarono un’exclave di quella che poi sarebbe stata la Repubblica Federale Tedesca all’interno del territorio della Germania Est, e quello sovietico (Berlino Est).

Berlino (24 giugno 1948 – 11 maggio 1949)
La prima crisi geopolitica significativa tra i due schieramenti si ebbe proprio con il blocco di Berlino. Di fatto, l’obiettivo dei Sovietici era di cacciare le truppe di USA, Regno Unito e Francia da Berlino e, il 24 giugno 1948, l’URSS bloccò gli accessi alla città, tagliando tutti i collegamenti stradali e ferroviari verso Berlino Ovest. Di fatto le parti occidentali della città furono scollegate dalla rete elettrica e Berlino Ovest divenne presto una città senza elettricità, viveri e medicinali. Il presidente Harry S. Truman, nonostante le proposte dei generali di forzare il blocco con un convoglio militare, decise di studiare la fattibilità di un ponte aereo che di fatto iniziò il 25 giugno e durò 462 giorni.

un Douglas C-54 in approccio finale al Flughafen Tempelhof – Photo by Henry Ries / Deutsches Historisches Museum Inventarnr
Centinaia di aeroplani trasportarono medicinali, viveri e carbone. Uno sforzo enorme durante il quale vennero effettuati oltre 278.000 voli, trasportando 2.326.406 tonnellate di cibo. Per il riscaldamento vennero trasportate 1.500.000 tonnellate di carbone, necessario per le esigenze elettriche e di riscaldamento. La crisi sfumò sotto gli occhi dell’Unione Sovietica che di fatto non fece nulla per fermare i voli umanitari statunitensi, britannici e francesi. Ma la tensione fra i due blocchi restò nell’aria.
Cuba (16 – 28 ottobre 1962)
Come reazione alla fallita invasione di Cuba nel 1961, che si sarebbe dovuta effettuare alla Baia dei Porci, ed alla presenza di missili balistici americani Jupiter dislocati sul territorio italiano e in Turchia, nel luglio 1962, il leader sovietico Nikita Chruščёv decise di “accettare la richiesta” di Fidel Castro di posizionare missili nucleari sull’isola al fine di scoraggiare una possibile futura invasione statunitense. Fu così che missili balistici a medio raggio (R-12) e intermedi (R-14) sovietici furono installati sulla costa cubana, a 90 miglia dalla Florida. La notizia venne confermata da un aereo spia Lockheed U-2 dell’USAF che raccolse evidenti prove fotografiche della loro presenza.

il blocco navale. Durante la crisi un P-3A Orion del Patrol Squadron VP-44 dell’US Navy sorvola il cacciatorpediniere DD-933 USS Barry e il mercantile sovietico Metallurg Anosov – U.S. Navy, Public Domain P-3A VP-44 over USS Barry (DD-933) and Metallurg Anosov during Cuban Missile Crisis 1962.jpg – Wikimedia Commons
Per reazione, gli Stati Uniti applicarono un blocco navale per impedirne l’arrivo di nuovi missili e chiesero che quelli già presenti fossero smantellati e restituiti all’Unione Sovietica. Alla fine venne raggiunto un accordo tra il presidente americano John F. Kennedy e quello russo Nikita Chruščёv, Gli Stati Uniti dichiararono l’intenzione di non tentare di invadere nuovamente Cuba e i Sovietici accettarono di ritirare da Cuba tutti i missili e i bombardieri leggeri Ilyushin Il-28 entro il 21 novembre 1962. Inoltre, sebbene non fosse stato incluso nell’accordo, gli Stati Uniti acconsentirono anche a smantellare i PGM-19 Jupiter schierati in Italia, Turchia e Gran Bretagna.
La necessità di una linea rossa per scongiurare un’escalation nucleare
Un effetto discendente fu la comune constatazione della necessità di avere una linea telefonica riservata, la linea rossa, tra Washington e Mosca. In quegli anni, in cui nascevano la NATO e il Patto di Varsavia, uno degli eventi più significativi, potremmo definirlo uno sfogo regionale delle tensioni fra i due blocchi, fu la guerra di Corea del giugno 1950. Un conflitto sanguinoso che vide coinvolti soldati americani in supporto ai coreani del sud contro i coreani comunisti del nord, supportati da consiglieri militari russi. Non fu l’unico evento e si ebbero sanguinosi scontri regionali che comportarono, in certi casi, degli orribili genocidi. Le invasioni sovietiche (per loro di polizia) in Ungheria e Cecoslovacchia mostrarono a tutto il mondo le differenze fra i due blocchi … A latere, la guerra fredda si combatté anche nella competizione verso lo spazio e in subdole attività politiche nei paesi occidentali, dove si generarono cellule estremiste armate che imperversarono negli anni bui del terrorismo.

gli eroi della resistenza Cecoslovacca in piazza durante l’invasione del 1968, (Image credit: WikiCommons)
Cold War
Quando George Orwell, pseudonimo di Eric Arthur Blair, coniò questo termine anticipò i contenuti dei suoi romanzi più importanti, La fattoria degli animali e 1984, che descrissero in maniera distopica i pericoli di un futuro mondo totalitario.
Orwell, pur essendo socialista, si rese presto conto del pericolo legato al comunismo di Stalin, la cui politica aggressiva e totalitaria avrebbe potuto prendere il controllo del mondo libero. Il termine guerra fredda da lui impiegato sul Tribune venne presto mutuato in ambito occidentale e, come accennato, fu in seguito usato dal consigliere presidenziale statunitense Bernard Baruch per inquadrare le crescenti tensioni tra le due potenze.

Operazioni di combattimento a Ia Drang Valley, Vietnam, novembre 1965. Un elicottero UH-1D pilotato dal maggiore Bruce P. Crandall si allontana dopo aver rilasciato alcuni soldati statunitensi della 1st Cavalry Division in un’azione di combattimento – Fonte US ARMY – Bruce Crandall’s UH-1D (cropped).jpg – Wikimedia Commons
La guerra fredda, di fatto, fu una guerra non dichiarata, combattuta per stabilire un’egemonia ideologica nel mondo, basata su principi spesso rigidi e poco visionari, usata da una classe non attenta ai cambiamenti culturali che stavano emergendo nel mondo.
Forse l’errore maggiore fu commesso dall’Occidente che, con il crollo inevitabile dell’Unione Sovietica, non seppe comprendere a pieno il momento storico. Il livello culturale medio dei cittadini, specialmente in Europa, era cambiato ed alle certezze imposte dai Governi, spesso non sufficientemente supportate dal punto di vista etico e morale, si associavano risposte di dissenso e ribellione. In altre parole, a livello politico non si comprese che quel mondo bipolare, divenuto improvvisamente unipolare a causa del crollo dell’Unione Sovietica, sarebbe diventato presto multipolare a causa dell’emergere di nuove realtà geopolitiche.

forze militari dei due blocchi nel 1959 – Toni di blu: Paesi membri della NATO – Toni di rosso : Paesi del Patto di Varsavia – Grigio: paesi neutrali – Verde: paesi non allineati comunisti – Spagna: neutrale 1959 NATO and WP troop strengths in Europe.svg – Wikimedia Commons
Anche nella NATO, il potere decisionale statunitense incominciò lentamente a declinare, non tanto per una maggior responsabilizzazione degli Alleati ma per il desiderio e necessità degli Stati Uniti di delegare il compito della difesa del teatro europeo ai Paesi membri. In quegli anni, gli Stati Uniti incominciarono a considerare l’ipotesi di instaurare relazioni bilaterali, in particolare nel settore orientale dove la Cina, che non aveva abbandonato la politica di Mao, stava incominciando a mostrare una politica che si sarebbe rivelata più chiaramente nei decenni a venire.
Il periodo storico, caratterizzato dal crollo dell’URSS, vide i Paesi dell’ex Patto di Varsavia cercare un’apertura straordinaria verso l’Occidente, chiedendo di unirsi all’Alleanza atlantica. Un’azione sicuramente non gradita alla Russia che però, a sua volta, mostrava un’apertura promettente. La storia ci dirà se l’Occidente perse un’occasione, forse unica, per sfruttare fenomeni sociali come la perestroika e la glasnost per incentivare la creazione di una democrazia reale in Russia. Di fatto la Russia, se da un lato creò un suo capitalismo favorito dal potere degli oligarchi, dall’altro non volle accettare un modus operandi con l’Occidente che sarebbe stato di comune vantaggio.
Se nel programma Russia-NATO si ottennero dei risultati importanti, dall’altro si notò una certa ritrosia da parte russa ad accettare una trasparente comunione di intenti. I generali russi in visita alla NATO spesso sottolinearono la volontà di voler recuperare l’eredità politico-militare dell’Unione sovietica, presentando programmi di sviluppo caratterizzati da armi sempre più letali da impiegare in ruolo difensivo. Un fattore che, in tempi di ristrettezze dei bilanci della Difesa, lasciò spesso perplessi i Paesi NATO.
La questione del nucleare
In quel periodo ebbero luogo gli accordi START (Strategic Arms Reduction Treaty), SORT e NEW START, tesi a diminuire gli arsenali di armi di distruzione di massa, in particolare le armi nucleari, che furono firmati dagli Stati Uniti e dall’URSS.

Scorte testata nucleare degli Stati Uniti e l’Unione Sovietica / Russia, 1945-2013. Questi numeri sono riserve totali, comprese le testate che non sono distribuiti attivamente (cioè, comprese quelle in stato di riserva o programmate per lo smantellamento). I numeri di testate attivi / operativi potrebbero essere molto più piccolo nel tempo presente, circa 5.700 per gli Stati Uniti e 5.800. Il numero maggiore per gli USA fu di 32.040 nel 1966; per l’URSS 45.000 nel 1986; il punto in cui l’URSS superò gli Stati Uniti nel 1978. Molte di loro erano però tattiche e non strategicheUS and USSR nuclear stockpiles-IT.svg – Wikimedia Commons
I trattati, che consentirono nel tempo l’eliminazione dell’80% delle armi nucleari in circolazione, portarono ad una riduzione sensibile delle spese di mantenimento degli arsenali militari. Al 2020, l’unico patto bilaterale fra Stati Uniti e Russia nonché l’unico trattato ancora vigente in materia di disarmo nucleare è il NEW START firmato nel 2011 da Barack Obama e Dmitrij Medvedev che, in estrema sintesi consente di mantenere per firmatario fino ad un massimo di 1.550 tra testate e bombe nucleari ed 800 vettori nucleari (Missili Balistici Intercontinentali (ICBM), Sottomarini Nucleari Lanciamissili (SLBM) e Bombardieri Pesanti) di cui 700 contemporaneamente operativi. Il trattato ha una validità decennale rinnovabile ed è stato esteso fino al 4 febbraio 2026. Nel 2020, la Federazione Russa ha dichiarato di avere, nonostante le sue capacità di trasporto strategico, 1.447 testate strategiche dispiegate.

missile russo IBCM SS 25 Topol – photo credit Army recognition
In sintesi, ci si rende facilmente conto che, al di là dei calcoli da ragioniere, le superpotenze hanno ancora una disponibilità bellica tale che, anche potenziando i reciproci sistemi di allarme e anti-missile, un attacco reciproco comporterebbe la fine della nostra civiltà sul pianeta. Si comprende che le pretese territoriali, attraverso stati cuscinetto, allo scopo di mantenere un buffer di sufficiente distanza fra i confini, trovano il tempo che trovano … un lancio massiccio da terra e dal mare sarebbe ugualmente devastante. Anche il concetto dei blocchi è superato dagli accordi economici transnazionali.

uno scontro economico tra i G7 e i paesi BRICS?
La guerra fredda è veramente finita?
Ricapitolando, la guerra fredda fu un periodo di tensione e ostilità che attanagliò la maggior parte del mondo tra gli anni Quaranta e l’inizio degli anni Novanta del secolo scorso. Le grandi crisi geopolitiche che si generarono fecero tenere il fiato sospeso a tutto il mondo, nella paura di scivolare nell’olocausto nucleare. Un periodo caratterizzato da conflitti locali con una forte connotazione ideologica, che provocarono un contributo doloroso di vite umane, da una parte e dall’altra. Da un lato si consolidò un sistema comunista, autocrate e dittatoriale, economicamente debole ed inteso a creare una società oligarchica in mano alla direzione del partito, dall’altro un sistema occidentale, democratico ma con ancora molte questioni irrisolte (questione razziale) con l’obiettivo di instaurare un capitalismo globale, competitivo e basato sull’individualismo, propugnato dagli Stati Uniti. Sebbene le imperfezioni dei due modelli, il sistema americano ebbe maggior successo mentre il sistema comunista collassò, portando al crollo dell’Unione Sovietica. In quegli anni il sistema mondiale divenne di fatto unipolare e adottò, nel bene e nel male, un modello di vita occidentale di stampo capitalista. Si assistette, con grande speranza, ad un importante cambiamento nelle relazioni internazionali per far fronte a quelle che sarebbero state identificate come le minacce del III millennio. Inizialmente, gli ex avversari modificarono le loro politiche, trovandosi a volte a collaborare insieme per la risoluzione di conflitti regionali. Negli Stati Uniti si fece strada il progetto di un nuovo ordine mondiale globale, inteso ad esportare su scala planetaria i principi della democrazia e del libero mercato. La globalizzazione, inizialmente esaltata, si rivelò però un fallimento geopolitico di disintegrazione sociale, con un incremento di fenomeni aberranti come l’ascesa del terrorismo internazionale ed i fondamentalismi transnazionali, strumenti dell’uno o dell’altro, per il controllo delle risorse energetiche. Al di là delle fantasie geopolitiche, relative alle teorie di complotto da parte di organizzazioni transnazionali, ciò che è certo che le vicende umane dei miliardi di persone sulla Terra si trovarono improvvisamente collegate fra di loro, cucite da fili invisibili viaggianti sulla rete. Giovani di tutti i continenti si trovarono improvvisamente partecipi inconsapevoli di un cambiamento epocale in cui il sistema, che si riteneva unico nocchiere del futuro dell’Umanità, si trovò impreparato.
Nel contempo, spesso in maniera sottile e poco visibile, avvenne un nuovo cambiamento, ancora in corso, in cui gli equilibri geopolitici sarebbero nuovamente cambiati. Il sistema di governo mondiale stava diventando multipolare con l’affacciarsi delle nuove superpotenze demografiche ed economiche. La lotta per le risorse sarebbe presto diventata una realtà: dall’Africa all’Asia, dalle terre più sperdute ai fondali degli oceani.
Ed il futuro?
Ed eccoci arrivati negli anni venti di questo secolo … appena iniziati ma caratterizzati da molte delle crisi preannunciate negli anni precedenti (l’Ucraina ne è un esempio calzante). La situazione attuale vede gli Stati Uniti, sebbene ancora sorretti da un’indubbia superiorità tecnologica, in una fase decadente, tra crisi interne economiche e sociali, che si trova a doversi confrontare con una Russia, in affanno ma alla ricerca di un’anacronistica affermazione militare a dimostrazione di un potere temporale che, in un mondo globalizzato, trova sempre meno giustificazioni. Due Superpotenze osservate da un Europa, spesso indecisa sul da farsi ed ancora frammentata internamente, da una Cina decisionista ed incurante del resto del mondo che prosegue la realizzazione machiavellica della sua via della seta, e non ultima un India tutt’altro che intenzionata a schierarsi ma non meno pericolosa. Le cose non vanno meglio in Sud America dove il gigante Brasile, nonostante le grandi risorse naturali, prosegue politiche sconsiderate dal punto di vista ambientale, circondandosi di aree crescenti di instabilità sociale.

A questo punto non possiamo più parlare di una guerra fredda fra due superpotenze ma di una situazione di instabilità geopolitica diffusa che fa presagire un mondo sempre più conflittuale, tra crisi economiche, demografiche ed energetiche nel III millennio. Non saranno necessariamente conflitti a livello regionale, molti si combatteranno in un nuova dimensione, quella cibernetica, che può causare danni altrettanto devastanti alle economie dei singoli Paesi. Non può nemmeno essere escluso l’impiego di armi tattiche nucleari, il cui possesso è ricercato dalle nuove superpotenze. Potremmo dire di trovarci in una palude dove ogni movimento deve essere effettuato con grande attenzione per non sprofondare, ogni tanto disturbati da bollenti getti che ci ricordano la nostra vera natura.
Una sorpresa per te su Amazon Music unlimited Scopri i vantaggi di Amazon Prime
Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo
PAGINA PRINCIPALE
- autore
- ultimi articoli
ammiraglio della Marina Militare Italiana (riserva), è laureato in Scienze Marittime della Difesa presso l’Università di Pisa ed in Scienze Politiche cum laude all’Università di Trieste. Analista di Maritime Security, collabora con numerosi Centri di studi e analisi geopolitici italiani ed internazionali. È docente di cartografia e geodesia applicata ai rilievi in mare presso l’I.S.S.D.. Nel 2019, ha ricevuto il Tridente d’oro dell’Accademia delle Scienze e Tecniche Subacquee per la divulgazione della cultura del mare. Fa parte del Comitato scientifico della Fondazione Atlantide e della Scuola internazionale Subacquei scientifici (ISSD – AIOSS).




































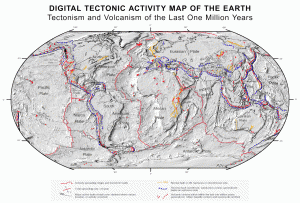





























Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.