.
livello elementare.
ARGOMENTO: STORIA NAVALE
PERIODO: XVI-XVIII SECOLO
AREA: MAR LIGURE
parole chiave: Genova
.
1. Le frontiere marittime genovesi: definizione, problemi e storiografia
Prima di parlare di come Genova gestì la difesa e il controllo delle sue frontiere marittime nei secoli dell’età moderna è opportuno definire quali fossero queste frontiere. Il termine frontiera applicato ad un territorio richiama con immediatezza il concetto di confine, cioè una linea che separa due entità territoriali. In geografia e nel diritto internazionale la frontiera coincide con la linea di confine che separa due stati, ma può avere anche un significato spaziale più ampio, ossia di zona di confine, concepita come una stretta striscia di territorio che sta a ridosso della linea di separazione.
Nel nostro caso, quindi, dovremmo considerare come frontiera marittima della Repubblica di Genova la linea costiera delle due Riviere liguri, o la stretta striscia di mare e di territorio litoraneo che gravita intorno a tale linea. In realtà, non è così, perché spesso di tende a dimenticare che la Repubblica di Genova comprendeva non solo il Dominio di Terraferma, corrispondente pressappoco all’attuale Liguria, ma anche quella grande isola che sta al di là del mar Ligure: la Corsica. La presenza della Corsica ci costringe a dilatare la nostra concezione della frontiera marittima della Repubblica, e a considerarla nel modo in cui era percepita ceto di governo genovese, vale a dire come uno spazio amplissimo compreso fra la striscia di territorio (inteso qui in senso lato, ossia tanto terrestre quanto marittimo) che gravita intorno alla linea costiera ligure, a nord, e le Bocche di Bonifacio, a sud. Una sorta di grande triangolo rovesciato che ha i propri vertici in Monaco, a ovest, Capo Corvo, a est, e Bonifacio a sud.
È meglio quindi parlare di frontiere, al plurale, in quanto si tratta, dal punto di vista della difese e del controllo del territorio, di un complesso di aree operative diverse che comprende le due Riviere liguri, i litorali della Corsica (con l’isola di Capraia) e la parte di mar Ligure delimitata dal triangolo. È chiaro quindi che stiamo parlando di un sistema alquanto permeabile, nella misura in cui i suoi fianchi a nordest e nordovest – caratterizzati da spazi di mare aperto difficili da controllare – risultavamo particolarmente vulnerabili. Si trattava quindi di un sistema ampio e complesso, e questo era vero non solo dal punto di vista geografico, ma anche da quello operativo, che doveva rispondere ad una serie di esigenze.
In primo luogo la difesa militare, in due principali ambiti strategici: la necessità di far fronte all’attività dei corsari barbareschi (nella sua duplice forma dell’incursione a terra e dell’azione predatrice in mare) e quella di proteggere il territorio ligure e còrso dagli appetiti, veri o presunti che fossero, delle potenze straniere. In secondo luogo il controllo del territorio, vale all’esercizio dei poteri di polizia, che, in ambito marittimo, comprendeva la lotta ai traffici illeciti (sia di frodo che di contrabbando) e i controlli di Sanità (vale a dire quel complesso sistema informativo-poliziesco volto ad impedire l’ingresso del “morbo pestifero”). In terzo ed ultimo luogo la tutela della giurisdizione della Repubblica sul mar Ligure di fronte alle violazioni commesse dei corsari stranieri duranti i conflitti fra le potenze europee.
Manca ad oggi uno studio monografico che tratti nel complesso la gestione militare e poliziesca delle frontiere marittime genovesi. Questo è un fatto abbastanza curioso visto che gli studi sui singoli temi non mancano, e molti sono stati realizzati, negli ultimi anni, dai miei colleghi del Laboratorio di Storia Marittima e Navale dell’Università di Genova, dal nostro maestro, Giovanni Assereto, e dal nostro direttore e coordinatore scientifico, Luca Lo Basso. Paolo Calcagno si è occupato di contrabbando e di lotta al contrabbando – così come chi scrive – e del problema della giurisdizione sugli spazi marittimi liguri, in particolare durante le guerre di Luigi XIV (Calcagno 2008, 2010, 2013, 2016).
I controlli di Sanità sono stati trattati da Giovanni Assereto in una monografia pubblicata nel 2011 (Assereto 2011). La Marina da guerra, indispensabile strumento di controllo del mare e difesa delle coste, è stata studiata, nelle sue molteplici declinazioni, da Luca Lo Basso, Vilma Borghesi, Gian Carlo Calcagno e da chi scrive (Borghesi 1973, Calcagno 1973, Beri 2011a, 2011b, 2013, 2016b, Lo Basso 2003, 2007, 2011). Infine, il complesso fortificatorio litoraneo è stato oggetto d’indagine da parte di numerosi studiosi còrsi (Graziani 2000 e 2001, Serpentini 2008) e genovesi (Marmori 1976, Calvino e Sarchi 1980, Fara 1983, Cevini 1984, Fara 1986, Forti 1992, Fedozzi 1998, Biagioni 2001, Beri 2015, Calcagno 2015).
2. La difesa e il controllo dei litorali e degli spazi marittimi: un sistema misto
Le forme di difesa e di controllo delle frontiere marittime nelle compagini statuali di antico regime si posso raggruppare in quattro categorie che sono, a due per due, antitetiche: terrestri e navali; statiche e mobili. Spesso queste forme sono state studiate attraverso due modelli relativamente rigidi, riconducibili il primo al binomio statico-terrestre e il secondo a quello mobile-navale. Il sistema genovese rientra tuttavia in entrambi i modelli: vale a dire che ha al suo interno sia elementi statici che mobili, e nessuno prevale in senso assoluto. Il predominio si verifica alternativamente, a seconda del contesto e del problema. Nei controlli di Sanità, ad esempio, la componente terrestre è sempre predominante e quella navale costituisce un elemento complementare. Nella risposta alla minaccia barbaresca, al contrario, la componente terrestre predomina solo nel XVI e nel primo quarto del XVII secolo – vale a dire finché sono presenti le incursioni a terra – mentre a partire dal momento in cui l’attività corsara si concentra quasi esclusivamente sul far prede in mare ecco che la componente navale, di riflesso, assume un ruolo centrale e quella terrestre viene relegata a compiti complementari (come la raccolta e la trasmissione di informazioni). In aggiunta la mobilità non è propria solo della componente navale: la presenza di squadre di cavalleria leggera nella Corsica orientale e nordorientale e nella giurisdizione Sarzana conferisce alla componente terrestre caratteristiche che male si sposano con la definizione di staticità.
Fine I Parte – continua
Emiliano Beri
in anteprima immagine dei una mappa del 1738 circa del mar Ligure – Fonte Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla File:1738 map of Ligurian Sea.jpg – Wikimedia Commons
testo tratto dalla relazione presentata al convegno internazionale “Navi genovesi nel Secolo dei Genovesi”, Archivio di Stato di Genova, 6 aprile 2018
.
Riferimenti bibliografici
– Assereto, Giovanni (2011), “Per la comune salvezza dal morbo contagioso”. I controlli di sanità nella Repubblica di Genova, Novi Ligure, Città del silenzio.
– Barbero, Alessandro (2010), Lepanto. La battaglia dei tre imperi, Roma-Bari, Laterza.
– Beri, Emiliano (2010), “Gênes et la Corse entre insurrection et guerre de succession d’Austriche (1741-1748)”, in Anne Brogini et Maria Ghazali (sous la dir. de), Des marges aux frontières, les puissances et les îles en Mediterranée à l’époque moderne, Paris, Garnier, pp. 287-342.
– Beri, Emiliano (2011a), “Genova e le marinerie del suo Dominio di fronte ai corsari di Pasquale Paoli (1755-1768)” in Enza Pelleriti (a cura di), Fra terra e mare: sovranità del mare, controllo del territorio, giustizia dei mercanti, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 95-119
– Beri, Emiliano (2011b), Genova e il suo Regno. Ordinamenti militari, poteri locali e controllo del territorio in Corsica fra insurrezioni e guerre civili (1729-1768), Novi Ligure, Città del silenzio.
– Beri, Emiliano (2013), “La marine génoise dans les guerres de la Corse (1729-1768)”, in Chronique d’Histoire Maritime, publication de la Société Française d’Histoire Maritime, n. 74, pp. 17-26.
– Beri, Emiliano (2015), “Défense et contrôle des littoraux de la Corse génoise (XVIe -XVIIIe siècles)”, in Anne Brogini e Maria Ghazali (sous la dir. de), La Méditerranée au prisme des rivages. Menaces, protections, aménagements en Méditerranée occidentale (XVIe-XXIe siècles), Paris, Bouchène, pp. 99-109
– Beri, Emiliano (2016a): “La lotta al contrabbando nel teatro marittimo còrso durante il medio Settecento fra polizia, intelligence e diplomazia”, in Livio Antonelli e Stefano Levati (a cura di), Contrabbando e legalità: polizia a difesa di privative, diritti sovrani e pubblico erario, Soveria Mannelli, Rubbettino.
– Beri, Emiliano (2106b), “La Compagnia di Nostra Signora del Soccorso: iniziativa privata e potere pubblico di fronte all’emergenza barbaresca nella Genova del Settecento”, in Enza Pelleriti (a cura di), Per una ricognizione degli stati di eccezione. Emergenze, ordine pubblico e apparati di polizia in Europa: le esperienze nazionali (secc. XVII-XX), Soveria Mannelli, Rubbettino.
– Biagioni, Marco (2001), I corsari barbareschi contro Genova e il Levante ligure. Secc. XVI-XVII: incursioni, difese, schiavitù, riscatti, rinnegati, La Spezia, Luna.
– Borghesi, Vilma (1973), “Il Magistrato delle galee (1559-1607)”, in Guerra e commercio nell’evoluzione della marina genovese tra XV e XVII secolo, Genova, Centro per la storia della tecnica in Italia CNR, pp. 187-223.
– Calcagno, Giancarlo (1973), La navigazione convogliata a Genova nella seconda metà del Seicento, in Guerra e commercio nell’evoluzione della marina genovese tra XV e XVII secolo, Genova, Centro per la storia della tecnica in Italia CNR, pp. 265-392.
– Calcagno, Paolo (2007), “Nel bel mezzo del Dominio”. La comunità di Celle Ligure nei Sei-Settecento, Ventimiglia, Philobiblon.
– Calcagno, Paolo (2008), “Al pregiudizio de la giurisdizione si aggiunge il danno pecuniario. Genova e la piaga del Finale nel XVII secolo”, in Società e Storia, n. 121, pp. 499-535.
– Calcagno, Paolo (2010), “La lotta al contrabbando nel mare Ligustico in età moderna: problemi e strategie dello Stato”, in Mediterranea, n. 20, pp. 479-532.
– Calcagno, Paolo (2013), “Genova, San Giorgio e il pattugliamento delle coste liguri a fini fiscali nel XVII secolo”, in Livio Antonielli e Stefano Levati (a cura di), Controllare il territorio. Norme, corpi, conflitti tra Medioevo e Prima guerra mondiale, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 189-212.
– Calcagno, Paolo (2015), “Une préoccupation récurrente pour Gênes: la défense de la rade de Vado aux XVIe-XVIIIe siècles”, in Anne Brogini et Maria Ghazali (sous la dir. de), La Méditerranée au prisme des rivages. Menaces, protections, aménagements en Méditerranée occidentale (XVIe-XXIe siècles), Paris, Bouchène, pp. 45-58.
– Calcagno, Paolo (2016), “Minacce dal mare: Genova e l’intensificazione della corsa durante le guerre di Luigi XIV”, in Enza Pelleriti (a cura di), Per una ricognizione degli stati di eccezione. Emergenze, ordine pubblico e apparati di polizia in Europa: le esperienze nazionali (secc. XVII-XX), Soveria Mannelli, Rubbettino.
– Calvino, Nilo e Sarchi, Aldo (1980), Corsari, sbarchi e fortificazioni nell’estremo Ponente ligure, Sanremo, Casabianca.
– Cevini, Paolo (1984), La Spezia, Genova, Sagep.
– Fara, Amelio (1983), La Spezia, Roma-Bari, Laterza.
– Fara, Amelio (1986), Il forte Santa Teresa nel Golfo della Spezia, Lerici, ENEA.
– Fedozzi, Giorgio (1998), Corsari e pirati in Liguria. Le scorrerie dei predoni turchi e barbareschi, i saccheggi, le deportazioni, la schiavitù e i riscatti, Imperia, Dominici.
– Forti, Leone Carlo (1992), Fortificazioni ed ingegneri militari in Liguria (1684-1814), Genova, Compagnia dei Librai.
– Giacomone Piana, Paolo e Dellepiane, Riccardo (2004): Militarium. Fonti archivistiche e bibliografia per la storia militare delle Repubblica di Genova (1528-1797), della Repubblica Ligure (1797-1805) e della Liguria napoleonica (1805-1814), Savone, Daner.
– Graziani, Antoine-Marie (2000), “Les ouvrages de défense en corse contre le turcs (1530-1650)”, in Antoine-Marie Graziani et Michel Vergé-Franceschi (sous la dir. de), La guerre de course en Méditerranée (1515-1830), Paris-Ajaccio, Presses de l’Université Paris Sorbonne-Piazzola, pp. 73-158.
– Graziani, Antoine-Marie (2001), “La menace barbaresque en Corse et la construction d’un système de défense (1510-1610)”, in Revue d’histoire maritime, nn. 2-3 (2001), pp. 141-162
– Lenci, Marco (2006), Corsari. Guerra, schiavi, rinnegati nel Mediterraneo, Roma, Carocci.
– Lo Basso, Luca (2003), Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna, Milano, Selene.
– Lo Basso, Luca (2007), “Gli asentisti del re. L’esercizio privato della guerra nelle strategie economiche dei Genovesi (1528-1716)”, in Rossella Cancila (a cura di), Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII), Quaderni Mediterranea, pp. 397-428.
– Lo Basso, Luca (2011), “Una difficile esistenza. Il duca di Tursi, gli asientos di galee e la squadra di Genova tra guerra navale, finanza e intrighi politici (1635-1643)”, in Manuel Herrero Sánchez, Yasmina Rocío Ben Yessef Garfia, Carlo Bitossi, Dino Puncuh (coor.), Génova y la Monarquía Hispánica (1528-1713), Genova, Società Ligure di Storia Patria, pp. 819-846.
– Marmori, Franco (1976), Fortificazioni nel golfo della Spezia, Genova, Stringa.
– Pacini, Arturo (1990), I presupposti politici del “secolo dei genovesi”. La riforma del 1528, Genova, Società Ligure di Storia Patria.
– Pacini, Arturo (1999), La Genova di Andrea Doria nell’impero di Carlo V, Firenze, Olschki.
– Pacini, Arturo (2013), “Desde Rosas a Gaeta”: la costruzione della rotta spagnola del Mediterraneo occidentale nel secolo XVI secolo, Milano, F. Angeli.
– Rossi, Luisa (2003), Lo specchio del Golfo. Paesaggio e anima della provincia spezzina, Sarzana, Agorà.
– Serpentini, Antoine-Laurent (2008), “Aspects du système défensif de la Corse génoise à l’époque moderne”, in Bruno Anatra et alii (a cura di), Contra Moros y Turcos. Politiche e sistemi di difesa degli Stati mediterranei della Corona di Spagna in Età Moderna, Cagliari, Istituto di Storia dell’Europa mediterranea CNR, pp. 297-298.
Una sorpresa per te su Amazon Music unlimited Scopri i vantaggi di Amazon Prime
Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo
- autore
- ultimi articoli
Emiliano Beri si è laureato con lode in Storia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova. Nel 2011 vi ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Storia, discutendo una tesi sulle guerre di Corsica del medio Settecento. Dal 2012 al 2016 è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia e Geografia dell’Università di Genova. Negli anni accademici 2016-17 e 2017-18 ha insegnato Storia sociale nel corso di Laurea triennale in Storia e Storia militare nel corso di Laurea magistrale in Scienze Storiche della Scuola di Scienze Umanistiche dell’Università di Genova. Per l’anno accademico 2018-19 è stato docente aggregato di Storia militare nel corso di Laurea magistrale in Scienze storiche della stessa Scuola. A partire dall’anno accademico 2019-20 è docente aggregato sia di Storia militare che di Storia sociale.




























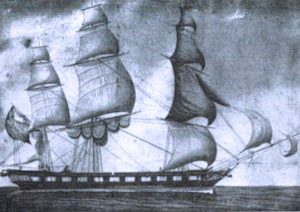








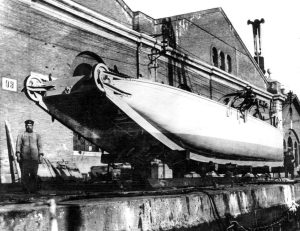


















Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.