.
livello elementare.
ARGOMENTO: REPORTAGE
PERIODO: XXI SECOLO
AREA: DARDANELLI
parole chiave: relitti
Dalle alture della penisola di Gallipoli si scorgono, a nord-ovest, sorgere scure e massicce dalle acque dell’Egeo l’isola greca di Samotracia e quella turca di Gökçeada (o İmroz Adası) – che durante la Prima Guerra Mondiale era greca e si chiamava Imbros. Dall’altra parte, verso sud, il canale dei Dardanelli segna come un ampio fiume il confine tra Europa e Asia; la sua importanza strategica è marcata dalle tante fortezze che ne presidiano le sponde.
Camminando sulle cime di queste colline, tra i profumi intensi e i colori verdi e bruni della macchia mediterranea, ci si può imbattere in un tratto di trincea, in un imponente cannone, o nelle lapidi bianche e ordinate di un cimitero militare: a oltre 100 anni di distanza sono le vestigia delle battaglie che insanguinarono questa penisola, trasformata in un’enorme fortezza a cielo aperto nel 1915.

i componenti della spedizione
E in effetti, ci si rende ben presto conto di trovarsi in un vero e proprio sacrario che custodisce, in una quiete a malapena rotta da gruppi di rispettosi visitatori, la memoria – oltre che le spoglie – di quanti persero la vita da una parte e dall’altra del fronte. Può stupire la quantità di idiomi che si ascoltano: Ellis Ashmead-Bartlett, corrispondente di guerra al seguito della Spedizione Alleata ai Dardanelli per conto della London Newspapers, la definì “la battaglia delle Nazioni” per via della varietà di provenienze dei soldati: accanto ai britannici e ai francesi vi erano scozzesi, irlandesi, australiani, neozelandesi, sikh, punjabi, gurkha, algerini, zuavi, senegalesi e marocchini. L’esercito ottomano, affiancato da quello tedesco, dimostrò una capacità di difesa incrollabile e, dopo oltre otto mesi di combattimenti, le forze alleate dovettero ritirarsi, lasciando sul campo un numero di vittime pari al tributo pagato dal fronte opposto.
Fu Mustafà Kemal, valoroso comandante nella Campagna di Gallipoli e in seguito primo Presidente della Repubblica Turca, così amato dal suo popolo da ricevere nel 1934 il nome di Atatürk (il Padre dei Turchi), ad accogliere i caduti di ogni nazione dichiarando: “Riposate in pace qui, per noi non c’è differenza tra i Johnny e i Mehmet che giacciono fianco a fianco nella nostra Terra. Quando hanno perso la vita nel nostro Paese, sono diventati anch’essi nostri figli.”

statua di Mustafà Kemal (Atatürk) a Chunuk Bair – foto dell’autrice
La campagna era nata come un’impresa navale, pianificata dall’Ammiragliato Britannico in accordo con la Marina Francese. L’obiettivo era quello di forzare lo Stretto dei Dardanelli, aprendo un nuovo fronte che avrebbe allentato quello del Caucaso e lo scontro nel cuore dell’Europa nella convinzione che si sarebbe arrivati ad una rapida resa di Costantinopoli e alla riapertura per gli alleati russi di una via di comunicazione con il Mar Mediterraneo.
La decisione dell’intervento navale fu presa all’unanimità dal Consiglio di Guerra britannico il 13 febbraio 1915. Sarebbero state impiegate corazzate di vecchia generazione, cosiddette pre-dreadnought, come la Majestic e la Canopus che potevano essere tolte dal principale scacchiere di guerra dove di fatto avevano compiti operativi secondari. Ma insieme a queste, si sarebbe inviata la prestigiosa Queen Elisabeth, la prima di cinque nuove corazzate e una delle più potenti navi della flotta britannica, che con i suoi cannoni da 15 pollici poteva bombardare le fortezze turche mantenendosi a distanza dalle batterie costiere nemiche. E inoltre due semi-dreadnought come l’Agamennon e la Lord Nelson.
La commissione che nel 1917 esaminò la Campagna dei Dardanelli mise in evidenza la vaghezza del piano approvato dal Consiglio: “come si poteva pensare che una flotta conquistasse una penisola o catturasse e occupasse una città come Costantinopoli?”. Di fatto c’era grande fiducia, e forse non del tutto mal riposta, nell’effetto che la potenza navale britannica avrebbe di per sé avuto su un Impero Ottomano da tempo in declino. Sotto il comando dell’Ammiraglio Sackville Carden una flotta mai vista prima nel Mediterraneo fece rotta a metà febbraio verso la bocca dei Dardanelli. Una prima offensiva per bombardare le fortezze turche fu lanciata il 19 febbraio, una seconda il 25. Con un’efficace tattica elusiva, l’esercito ottomano scompariva durante i bombardamenti per riapparire appena questi terminavano, la sua artiglieria si concentrava sui dragamine, rendendo molto difficili le loro operazioni.
Il 18 marzo 1915 l’Ammiraglio De Robeck, che aveva sostituito il troppo incerto Carden, sferrò l’attacco principale entrando nei Dardanelli con un primo gruppo di dieci corazzate, seguito a distanza di un miglio da un secondo gruppo di navi sotto comando francese e infine da una terza linea di navi britanniche.

in poco tempo si capovolge portando con se 600 uomini French battleship Bouvet capsizes, killing over 600 men, after having struck a mine in the Dardanelles on 18 March 1915 during the Battle of Gallipoli. (12558878113).jpg – Wikimedia Commons
Dopo circa due ore e mezza di fuoco incrociato, un colpo dell’artiglieria pesante turca centrò la nave francese Bouvet, facendone esplodere i depositi delle munizioni e affondandola in meno di due minuti insieme a oltre 600 uomini di equipaggio. Altri incidenti funestarono la lunga giornata, alla fine della quale il bilancio delle forze anglo francesi era di tre navi perse e una quarta gravemente danneggiata. Ignorando l’effetto che i bombardamenti avevano avuto sul fronte ottomano, si decise di sospendere l’operazione.
Malgrado Churchill avesse dichiarato che “inevitabili perdite erano da mettere in conto”, il timore di altri affondamenti spinse alla risoluzione che la flotta da sola non poteva conquistare i Dardanelli, era necessario attendere l’arrivo dell’esercito per organizzare un’offensiva congiunta. Tra gli alti comandi a Londra si era a lungo discusso dell’opportunità di affiancare all’azione navale uno sbarco di forze armate nella Penisola di Gallipoli. Il più contrario a questa scelta era stato il Ministro della Guerra Lord Kitchener, che riteneva sbagliato togliere Divisioni da altri fronti e che inizialmente aveva osteggiato l’intera campagna. Non era stato il solo, diversi ammiragli avevano manifestato forti perplessità sul piano delineato dal Primo Lord dell’Ammiragliato Winston Churchill, ma alla fine il giovane e brillante uomo politico aveva avuto la meglio sulla visione più pragmatica dei militari.
Ora la decisione di interrompere le operazioni in attesa dello sbarco contrariò Churchill prima di tutti: il tempo necessario per organizzarlo andava a scapito di qualsiasi ipotesi di effetto sorpresa, ma non si poteva forzare il giudizio degli ammiragli sul campo.
Denominata Mediterranean Expeditionary Force, la spedizione che seguì fu la più grande operazione del suo genere mai concepita fino ad allora. Dopo un periodo di addestramento in Egitto, una quantità di imbarcazioni di ogni genere si radunò nella baia di Mudros, nell’isola di Lemnos, scelta come base delle operazioni. Insieme a corazzate, incrociatori e numerose navi militari, vi erano imbarcazioni da diporto, caicchi, pescherecci… pronti a trasportare a terra uomini, merci e animali. Il 25 aprile alcune decine di migliaia militari sbarcarono in diversi punti della penisola, tra questi gli uomini della 29ma divisione, una delle migliori unità dell’esercito britannico, due divisioni australiane e neozelandesi già di stanza in Egitto denominate ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps) che celebreranno su questa penisola la nascita della loro leggenda, e poi una divisione francese e una divisione della Royal Navy. Si riteneva che in breve tempo la Penisola sarebbe stata conquistata e le postazioni armate sullo stretto neutralizzate.

cannoni e obici turchi – museo di Cannakale – foto dell’autrice
Tuttavia, gli errori di valutazione furono molti e nefasti, a incominciare dal fatto che l’esercito ottomano, sotto il comando del generale tedesco Otto Liman von Sanders, aveva avuto tutto il tempo per organizzare la difesa di una penisola, scelta originariamente perché priva di guarnigioni militari sulle coste nord-occidentali. Ma vi fu anche una sottostima delle forze messe in campo dai turchi e della loro tenace capacità di difesa. Un altro grave problema era la mancanza di carte dettagliate del territorio per elaborare una strategia di attacco che sfruttasse al meglio le potenzialità delle divisioni in campo, oltre a consentire la sopravvivenza sul posto: c’era acqua? c’erano strade? e abitazioni? non si sapeva nulla. I molti interrogativi erano alla base della mancanza di un realistico piano di azione.
I pendii che dalla cresta di Sari Bahir scendono al mar Egeo sono segnati da gole e dirupi scavati nel tempo dall’azione del vento, della pioggia e delle tempeste invernali sulla tenera roccia calcarea. Gli sbarchi avvennero in punti dai quali era molto difficile poter avanzare verso l’interno, non parliamo di poter attraversare la penisola verso le fortificazioni sui Dardanelli. Sotto il tiro costante del nemico, che dall’alto delle ripide pareti godeva di una mobilità ben protetta, le truppe giungevano a terra a bordo di lance e pontoni sui quali erano così stipate, spalla contro spalla, che a volte non si riusciva nemmeno ad alzare il fucile per difendersi.
Era un facile tiro al bersaglio per i turchi, una carneficina per gli alleati: molti soldati morivano senza aver nemmeno messo piede a terra, altri annegavano sotto il peso delle attrezzature saltando dalle imbarcazioni prima che queste avessero raggiunto le acque basse. Quelli che riuscivano a sbarcare erano costretti a scavarsi rapidamente un riparo sotto le cenge di roccia e da qui sferrare attacchi frontali dagli esiti deleteri. La sola operazione che si svolse con successo fu lo sbarco della divisione francese sulla costa asiatica, dove non si incontrò nessuna resistenza. Alla fine di quella tragica giornata nessuno degli obiettivi era stato raggiunto. Incominciò da quel momento quella drammatica guerra di trincea che già si conosceva sul fronte occidentale, ma in questo caso in un territorio remoto, disabitato e sconosciuto, la cui discontinuità rendeva estremamente difficili delle offensive coordinate: appena un gruppo risaliva una gola perdeva contatto con i compagni anche solo 50 metri più in là. Obiettivi apparentemente a portata di mano diventavano, in queste condizioni, impossibili da raggiungere.
E poi c’erano i turchi, incrollabili nella loro difesa e comandati da militari lucidi e infaticabili, come Mustafà Kemal che il territorio lo conosceva bene e sapeva sempre come e dove rispondere agli attacchi nemici. Il ruolo della Marina cambiò rispetto ai piani originari, in attesa di una terza fase nella quale – neutralizzate via terra le difese ottomane sui Dardanelli – avrebbe raggiunto trionfalmente Costantinopoli e il Mar di Marmara. A quella fase, tuttavia, non si arrivò mai.

La fine del HMS Irresistible. Il 18 marzo la nave urtò una mina navale che causò vasti allagamenti ed il blocco dei motori. Alla deriva finì nel raggio dei cannoni turchi, che la colpirono a morte. I tentativi di rimorchiarla fallirono ed alla fine il suo equipaggio fu evacuato mentre la nave affondava portando con se circa 150 marinai – da Lot-11259-15: WWI – Royal Navy. Royal Navy battleship, HMS Irresistible, May 4, 1915. She was hit by Turkish artillery then sunk by a mine from Turkish minelayer Nusret. George C. Bain Collection. Courtesy of the Library of Congress, LC-USZ62-110854. (2016/10/14) – National museum of the U.S. Navy – File:Lot-11259-15 (30238939981).jpg – Wikimedia Commons
Le unità da guerra della Marina pattugliavano la costa, trasportando il Quartier Generale da un avamposto all’altro, e soprattutto coprendo o anticipando le azioni militari con pesanti bombardamenti a distanza delle linee ottomane.

mine ormeggiate turche conservate al museo di Cannakale – foto dell’autrice
La situazione cambiò ulteriormente quando, nel mese di maggio, fecero la loro comparsa i sommergibili. Sistemi di scansione dei fondali erano ancora allo studio, non si conosceva a sufficienza la propagazione delle onde sonore in acqua, e le navi erano del tutto impotenti di fronte ad una minaccia che proveniva dalle profondità marine. Ben due sottomarini inglesi, l’E14 del comandante Edward Boyle e l’E11 del comandante Martin Nasmith, avevano raggiunto il Mar di Marmara attraverso i Dardanelli tra la fine di aprile e il mese di maggio, affondando un buon numero di imbarcazioni turche, diffondendo ottimismo tra gli Alleati e panico a Costantinopoli. Ma quando il 25 maggio il comandante tedesco Otto Hersing a bordo del sommergibile U21 affondò la corrazzata Triumph, il panico invase anche la Marina anglo-francese.
De Robeck, che già aveva spostato il suo Quartier Generale dalla Queen Elisabeth alla Lord Nelson, si trasferì in gran fretta sul Triad, un’imbarcazione da diporto che prima della guerra navigava pacificamente nel Bosforo. Le navi più importanti furono ritirate nella baia di Mudros, lasciando un vuoto lungo le coste che le truppe alleate in trincea percepirono come un segno di fallimento. E sotto gli occhi dei soldati di entrambe le parti del fronte, due giorni dopo l’affondamento della Triumph fu la volta della corrazzata Majestic colpita da un siluro dello stesso U21. Il 4 luglio Hersing colpì un’ultima volta, per affondare il mercantile francese Carthage, infine lasciò le acque dei Dardanelli alla volta del Mar Adriatico.
Sommergibili inglesi della classe E continuarono a percorrere i Dardanelli, non senza incidenti e affondamenti, raggiungendo comunque il risultato di spostare il trasporto dei rinforzi ottomani dall’acqua alla terra, lungo percorsi complessi che richiedevano tempi molto più lunghi. Ma per gli Alleati fu sufficiente l’azione dell’U21 per sconvolgere i piani della Marina e demoralizzare ulteriormente gli animi, facendo percepire sempre più imminente e necessaria la conclusione di questa offensiva. In autunno, dopo un nuovo sbarco in agosto, un numero enorme di vittime e l’inverno che incombeva con condizioni di vita insopportabili in trincea, non erano stati raggiunti nemmeno gli obiettivi di quel lontano 25 aprile.

foto della baia di Suvla – foto dell’autrice
Ai primi di dicembre si incominciarono ad evacuare le truppe dalle baie di Suvla e Anzac, e poco dopo da Cape Helles. Malgrado i timori degli alti comandi, fu l’operazione meglio organizzata dell’intera Campagna: si concluse il 9 gennaio senza lasciare sul campo nemmeno un morto.
Fine I parte – continua
Marina Cappabianca
.
.
Una sorpresa per te su Amazon Music unlimited Scopri i vantaggi di Amazon Prime
Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo
- autore
- ultimi articoli
Produttrice, autrice e regista di documentari, ha consolidato una forte esperienza nel campo delle produzioni internazionali dapprima con Brando Quilici, negli Stati Uniti e in Canada; successivamente in oltre 10 anni di attività con la società Paneikon, accreditata sui mercati mondiali per la qualità delle sue produzioni documentaristiche; infine in partnership con Pippo Cappellano nella società Capmar Studios specializzata in documentari subacquei, naturalistici e storici. Ha coordinato numerose coproduzioni internazionali con partner quali Discovery, National Geographic, WGBH Nova, WDR e ZDF in Germania, BBC, France 2, France 3, France 5. Ha realizzato come autrice e regista diversi documentari di natura per RAI e Mediaset, ha pubblicato articoli su tematiche relative all’attività del documentario. Ha fatto parte di giurie di prestigiosi festival internazionali di documentari quali Mountain Film Festival di Telluride in Colorado, Science Media Award di Boston, Wildlife Film Festival di Jackson Hole, DocScient di Roma. Dal 2009 al 2014 è stata Direttore Artistico del Festival Internazionale di Documentari Subacquei “Pelagos” di Roma. Subacquea, velista, appassionata di montagna, parla correntemente inglese, tedesco, francese e spagnolo.





































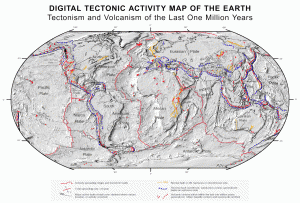





























Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.