ARGOMENTO: ARCHEOLOGIA DELLE ACQUE
PERIODO: I SECOLO a.C.
AREA: MAR MEDITERRANEO – MAR LIGURE
parole chiave: nave di Albenga
.
Spesso i ritrovamenti in mare sono dovuti a casualità; quello della nave romana di Albenga fu dovuto alla pesca fortuita di tre anfore da parte di un pescatore della zona, Antonio Bignone che, pescando a strascico, nel 1925 le recuperò per caso nelle sue reti. A quell’epoca era impensabile operare un recupero ad una profondità di circa 40 metri per cui il primo intervento di scavo archeologico sul relitto fu tentato dopo un quarto di secolo, nel secondo dopo guerra. Era il 1950 quando la Società Sorima del commendatore Giovanni Quaglia, reduce dal recupero dell’oro dell’Egypt, effettuò il primo recupero di anfore (dal 8 al 20 febbraio 1950) sotto la guida di Nino Lamboglia, pioniere dell’archeologia subacquea mediterranea e fondatore del celebre Istituto Internazionale di Studi Liguri.
I marinai conoscono bene le insidie del mar Ligure che ancor oggi mietono vittime tra i pescatori che incautamente vengono colti nelle improvvise tempeste spinte dai venti freddi di Maestrale. Si trattava di una nave da carico del tipo corbita che, intorno al I secolo a.C., trasportava un carico di anfore vinarie probabilmente dalla regione della Campania verso la Gallia Narbonense. Una tempesta l’aveva colta durante il suo trasferimento costiero e la nave era affondata con il suo ingente carico. Questo tipo di nave era il più grande tra le navi onerarie romane con una lunghezza di oltre 40 metri, una larghezza di dieci metri ed una capacità di carico stimata tra le 11.000 e le 13.000 anfore tipo Dressel 1 aveva una stazza lorda intorno alle 600 tonnellate. Il relitto giace ad una profondità di circa 40 metri ed i palombari dell’«Artiglio», in poco meno di un mese, effettuarono il recupero di ben 728 anfore e molto vasellame. Sulla nave furono ritrovati anche gli elmi dei soldati imbarcati a protezione del carico in caso di attacco da parte dei pirati. Le anfore in origine contenevano prevalentemente vino ma anche …. delle nocciole. Interessante fu la scoperta che le anfore erano state impermeabilizzate con uno spesso strato di resina o pece ed erano tappate ermeticamente con sugheri di sette centimetri di diametro infilati nella parte più stretta del collo e poi sigillati con malta di calce. Le anfore ritrovate erano del tipo “Dressel 1B“, dal nome dello studioso tedesco Henrich Dressel che nel 1891 elaborò la famosa tavola riassuntiva dei 45 tipi diversi di anfore rinvenute a Roma presso il Castro Pretorio. Molte delle anfore recuperate presentavano danni nella parte superiore, probabilmente causati dalle reti a strascico ma anche dalla famigerata benna dell’Artiglio. Un uso nefasto che fu in seguito sottolineato dallo stesso Lamboglia che andò in aperto contrasto con le tecniche di recupero dell’epoca che utilizzavano principalmente la benna. Col senno del poi lo scavo dell’«Artiglio» fu considerato un esempio negativo di scavo archeologico. Ci si rese conto che, al di là dei reperti singoli, i relitti assumevano una significatività maggiore quando potevano fornire informazioni non solo sul loro carico ma sui mezzi, strutture e tecnologie presenti a bordo. I materiali recuperati furono subito esposti al pubblico in locali messi a disposizione dal Comune di Albenga. Tra le lezioni apprese, si incominciò a comprendere la tecnica di stivaggio delle anfore a bordo delle onerarie, distinguendo quelle appartenenti al carico da quelli in dotazione per i servizi di bordo.
I precedenti

una delle navi di Nemi- museo delle navi di Nemi
Precedentemente il Ministro della Pubblica Istruzione e quello della Marina militare avevano progettato lo scavo ed il recupero degli scafi del lago di Nemi che erano stati in passato già devastati. Gli studi furono affidati al tenente colonnello del Genio Navale ingegnere Vittorio Malfatti.

disegno di una delle navi di Caligola – museo delle navi di Nemi – photo credit @andrea mucedola
Malfatti, dopo aver eseguito un rilievo generale del lago, concluse che l’unica via attuabile per il recupero degli scafi fosse l’abbassamento del livello delle acque del lago, così da di porre in secco le due imbarcazioni. L’opportunità finalmente si concretizzò dopo il discorso effettuato da Mussolini il 9 aprile 1927 quando annunciò la volontà di portare alla luce le due navi. Guido Ucelli, Consigliere Delegato e Direttore Generale della Società costruzioni meccaniche Riva di Milano, che produceva pompe e turbine idrauliche, ed altri imprenditori si offrirono gratuitamente al Governo italiano per l’operazione che venne condotta con grande rigore tecnico e scientifico e fornì informazioni importantissime sulla tecnica navale romana. Il resoconto del recupero, i rilievi, le indagini, le analisi furono poi pubblicati da Ucelli e da altri studiosi nel volume Le navi di Nemi, pubblicato in diverse edizioni dal Poligrafico e Zecca dello Stato (1940). Un bagaglio di esperienze inestimabile che pose le basi per le ricerche successive.
Dopo il recupero delle navi di Nemi, i lavori effettuati sulla nave di Albenga furono il primo vero tentativo di scavo di un relitto antico in mare effettuato in Italia. Nel 1957, con la creazione del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina di Albenga, ci si rese conto che la campagna di scavo doveva essere condotta attraverso metodi di rilevamento più accurati che, nel 1958-59, vennero applicati sul relitto di Spargi (arcipelago della Maddalena). Sul relitto venne steso, per la prima volta, un sistema di quadri di rilievo in tubi rigidi formanti una rete di copertura del relitto. Le maglie di cm. 150 x 150 furono fotografate ed il fotomontaggio dell’insieme dei quadri consentì una visione di insieme mai ottenuta precedentemente. Il successo dell’operazione di scavo suggerì un metodo più scientifico per le successive ricerche sull’oneraria di Albenga.
Nel 1961 i tecnici della Sovrintendenza posero sulla nave di Albenga una rete composta da ben 192 quadrati. I dati raccolti consentirono di comprendere che il carico era disposto su una lunghezza di circa 26 metri su una larghezza di 7,50. Lo scavo successivo, lateralmente sulla parte centrale verso poppa, permise “di accertare che vi era stato un rapido insabbiamento del fondale dopo il naufragio e un riempimento di fango, proveniente dal vicino fiume Centa che fino agli inizi del Trecento sboccava di rimpetto al relitto”.
Nello scavo, nella zona poppiera, vennero ritrovatati anche frammenti di tegole e di un embrice integro. Ma fu negli scavi successivi, effettuati nel 1970 e 1971, che si ottenne una scoperta straordinaria: gli strati di anfore impilate fa di loro, erano come minimo quattro. Vennero portate alla luce tre ordinate (larghe circa 14 cm. ed alte cm. 12) distanti tra di loro una decina di centimetri, resti del fasciame esterno (spesso 9 cm.) e di quello interno (spesso 5 cm.). Inoltre, fu ritrovata una lamina di piombo di protezione contro le teredini con chiodature in rame che la fissavano al fasciame esterno. L’insieme diede la possibilità di ricostruire la sezione dello scafo. Venne anche trovata ceramica a vernice nera impilata negli spazi vuoti tra le anfore, tra i diversi elementi lignei della nave. Un sistema geniale di mantenere quegli elementi ceramici, tutto sommato fragili, fermi tra le anfore. Tra i quadri 119 e 120 fu scoperto anche l’albero centrale della nave (del diametro di cinquanta centimetri).
Dai risultati ottenuti nelle diverse campagne emerse che la nave onoraria aveva dimensioni maggiori di quanto previsto, con una larghezza di circa dieci metri ed una lunghezza di cinquanta metri. Il carico utile poteva essere stato di circa diecimila anfore e il dislocamento 450 tonnellate. Un gigante del mare per l’epoca. Tra i materiali del carico furono recuperati otto elmi bronzei, forse a disposizione dell’equipaggio in caso di attacco da parte dei tanti pirati che all’epoca imperversavano in quelle acque.
Curiosi furono anche i ritrovamenti di un corno di piombo, lungo 26 cm, che si suppone fosse stato collocato a prua oppure nella parte superiore della cabina della nave con funzione scaramantica, e di un crogiolo realizzato con un minerale duro e quarzoso che doveva essere utilizzato per fondere il piombo in caso di urgenti saldature e riparazioni a bordo. In sintesi un relitto che fornì un insieme di informazioni importantissime sulla navigazione romana. Se visiterete Albenga non mancate di visitare il Museo Navale di Albenga dove potrete vedere molti dei reperti raccolti dal relitto.
Il sito
La nave di Albenga può essere considerata ancora oggi uno dei più grandi relitti di navi onerarie romane del Mediterraneo del I secolo a.C. Dal 2014 il sito subacqueo è finalmente visitabile ma solo durante aperture straordinarie stabilite dal Ministero dei Beni culturali. E’ obbligatoria la prenotazione. Per maggiori informazioni potete contattare la Guardia Costiera o i diving locali.
Potete contattare anche Corrado Ambrosi del Centro di Formazione istruttori PADI Marina Diving al telefono +39/3356611106 oppure inviando una email al marinadiving@marinadiving.com.
Attenzione
Le discese e le risalite avvengono rigorosamente seguendo cime appositamente collocate per i subacquei. I diving locali e autorizzati possono sostare in superficie ed attendere che i subacquei effettuino le loro esplorazioni. Le anfore ricoprono ancora un’area lunga 40 metri e larga 16. Le anfore visibili sono numerosissime, molte ancora intatte e le stesse sono diventate la tana di gronghi e murene. Nell’attesa non ci resta che visitarlo virtualmente con questo video di InfoRmare, Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale per la pratica, la promozione, lo sviluppo e la diffusione dell’attività legate all’ambiente marino … buona visita.
in anteprima: le anfore del museo navale romano, allestimento che ne mostra la disposizione in una nave da carico dell’epoca – photo credit @Giacomo Cellerino
Anfore palazzo Peloso Cepolla.jpg – Wikimedia Commons
Bibliografia
GUIDO UCELLI, Le navi di Nemi. Roma, 1940 | E.75
CORRADO RICCI, Gloriose imprese archeologiche : il Foro d’Augusto a Roma, le navi di Nemi, Pompei ed Ercolano. – Bergamo, 1927 | D.1985
GUIDO UCELLI, Il contributo dato dalla impresa di Nemi alla conoscenza della scienza e della tecnica di Roma. Milano, 1943 | MISC D.799
GUIDO PO, Il contributo della Marina al ricupero delle navi di Nemi. Roma, 1940 | MISC D.795
G.C. SPEZIALE, Delle navi di Nemi e dell’archeologia navale. Roma, 1930 | MISC D.790
NINO LAMBOGLIA, Diario di scavo a bordo dell’« Artiglio,,, in Riv. lng. e / nt., N.S., A.V., n. 1, 1950, pp. 1-8;
NINO LAMBOGLIA, La Nave Romana di Albenga, in Riv. di St. Lig., A. XVIII, n. 3-4, 1952, pp. 131-213;
NINO LAMBOGLIA, ouilles à Albenga, in Bulletin Officiel du Club Alpin-Sous-marin, n. 8, Rapport du Premier Congres Internationale d’Archéologie Sous-marine, 1956, p. 18 e segg.;
NINO LAMBOGLIA, Scavi sottomarini del 1960 ad Albenga. in Riv. lng. e lnt., A. XV, 1960, n. 1-3, p. 73; NINO LAMBOGLIA, Il rilevamento totale della Nave Romana di Albenga, in Riv. lng. e 1nt., A. XVI, 1961,n. 3-4, pp. 106-108;
NINO LAMBOGLIA, Il rilevamento della Nave Romana di Albenga , in Riv. di St. Lig., XXVII, n. 1-4, 1961, pp. 213-239;
NINO LAMBOGLIA, Il primo saggio di scavo sulla Nave Romana di Albenga , in Riv. Ing. e lnt., N.S., XVII, 1962, pp. 73-75;
NINO LAMOGLIA, Il rilievo totale della Nave Romana di Albenga , in Atti del IIl Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina (Barcellona 1961), Bordighera, 1971, pp. 167-175;
NINO LAMBOGLIA, L’ottava e la nona campagna di scavi sottomarini (1970-1971) sulla Nave Romana di Albenga , in Riv. lng. e lnt., N.S., A. XXV_I. 1971, n, 1-4, PP·. 71-7;
FRANCISCA PALLARÉS, Dalla Nave Romana di Albenga a quelle d1 Porto Venere e Diano, Rivista di attualità economiche e culturali dell’ Istituto Banca rio San Paolo di Torino, A. 5, n. 1
.
Una sorpresa per te su Amazon Music unlimited Scopri i vantaggi di Amazon Prime
Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo
,
- autore
- ultimi articoli
ammiraglio della Marina Militare Italiana (riserva), è laureato in Scienze Marittime della Difesa presso l’Università di Pisa ed in Scienze Politiche cum laude all’Università di Trieste. Analista di Maritime Security, collabora con numerosi Centri di studi e analisi geopolitici italiani ed internazionali. È docente di cartografia e geodesia applicata ai rilievi in mare presso l’I.S.S.D.. Nel 2019, ha ricevuto il Tridente d’oro dell’Accademia delle Scienze e Tecniche Subacquee per la divulgazione della cultura del mare. Fa parte del Comitato scientifico della Fondazione Atlantide e della Scuola internazionale Subacquei scientifici (ISSD – AIOSS).



























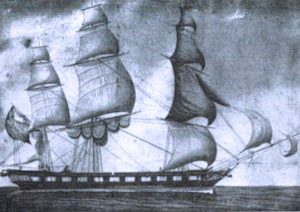









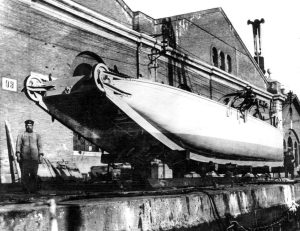


















Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.